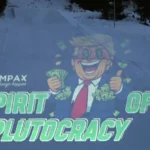Mentre in Cisgiordania i coloni costruiscono nuovi avamposti sotto la protezione dell’esercito e a Gaza le rovine parlano più delle diplomazie, in Israele cresce un’altra frattura, invisibile e dolorosa: quella della coscienza. È la guerra interiore di un popolo che non riesce più a distinguere tra difesa e vendetta, tra giustizia e paura.
Una crisi di legittimità.
In un’analisi pubblicata su Haaretz, il giornalista Joshua Leifer denuncia la violenza crescente dei coloni nella Cisgiordania occupata: oltre mille palestinesi uccisi in due anni, villaggi svuotati, comunità distrutte. Tutto spesso sotto lo sguardo complice dell’esercito.
Leifer scrive che «i coloni non possono più nascondere la realtà della loro brutalità, come non potevano nascondere Gaza».
Dietro la retorica della sicurezza, si profila un collasso morale: Israele, nato per difendere la vita, rischia di diventare una società che la vita la domina.
Yocheved e il sogno di Oded.
In questo scenario, la voce di una donna ottantacinquenne risuona come un sussurro di profezia.
Yocheved Lifshitz, rapita da Hamas nel kibbutz Nir Oz e poi liberata, ha raccontato il suo sogno di qualche notte dopo il ritorno dalla prigionia: il marito Oded, pacifista e fondatore del kibbutz, ucciso il 7 ottobre 2023, le inviava una canzone di Georges Brassens, “Non ti chiederò la mano”.
«Era come se mi dicesse di non possedere, ma amare», confida.
“Mi sento tradita dal mio Paese”, ha aggiunto. “Abbiamo creduto che la pace fosse possibile, ma ci hanno lasciati soli, disarmati.”
Oded Lifshitz aiutava i palestinesi ad attraversare i check-point per ricevere cure mediche. Credeva che la convivenza fosse la forma più alta di sicurezza. Oggi i suoi scritti, pubblicati postumi, testimoniano una fede civile fatta di rispetto e dialogo: «La pace non è un patto tra eserciti, ma tra cuori che non hanno smesso di credere.»
La ferita morale dei soldati.
Intanto, nelle cliniche di Tel Aviv, lo psicologo Yossi Levi-Belz riceve i soldati tornati da Gaza. Non soffrono solo di stress post-traumatico, ma di una “moral injury”, una ferita morale.
«Non è paura, è colpa», spiega. «È lo scarto tra ciò che hai fatto e ciò che credevi giusto».
Molti non riescono più a dormire. Rivedono i volti dei civili uccisi, i bambini sotto le macerie. Non sono traditori: sono giovani che scoprono di non poter tornare gli stessi dopo aver visto troppo.
La loro sofferenza non è debolezza, ma l’ultimo segno che la coscienza d’Israele non è del tutto spenta.
Un popolo stanco di sangue.
Tre voci — un giornalista, una vedova, uno psicologo — raccontano oggi lo stesso dramma: la coscienza ferita di Israele.
Dietro il rumore dei cannoni si fa strada un dubbio: la forza senza giustizia può ancora dirsi sicurezza?
Yocheved Lifshitz, sopravvissuta e credente nella pace, risponde con la dolcezza di una madre: la pace è sempre possibile, ma non con chi rifiuta di guardare il volto dell’altro.
È questa la frontiera morale del Paese, quella che nessun muro può difendere e nessuna guerra può vincere.
Israele deve scegliere se essere una terra promessa o una terra di paura; se restare fedele al sogno dei profeti o smarrirsi tra i coloni armati e la rassegnazione dei giovani in divisa.
La pace come coscienza.
“Cercate la pace e perseguitela”, ricorda il Salmo.
Oggi questo versetto sembra rivolgersi prima di tutto a chi, in Israele, sente che la fede dei padri non può essere ridotta a un atto di forza.
Leifer, Yocheved e Levi-Belz — ciascuno a modo suo — indicano la stessa via: non negare la realtà, non odiare, non cedere alla menzogna della paura.
Forse la vera rinascita comincerà proprio da lì: dal riconoscere che anche chi ha vinto può sentirsi perduto, e che solo chi accetta la propria ferita può tornare a curare quella del mondo.