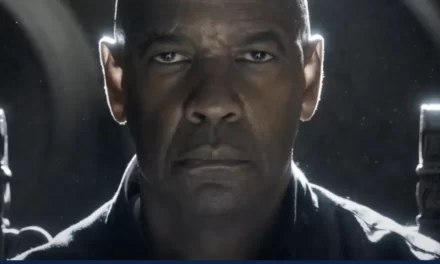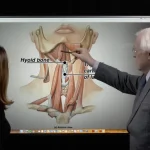Quando si parla dell’Iran, il discorso pubblico occidentale si concentra quasi sempre su repressione, censura e conflitti. È giusto e necessario denunciare le violazioni dei diritti umani, specie quelle che colpiscono le minoranze etniche e le donne curde, ma ridurre una nazione millenaria a questa sola dimensione significa amputarne la verità più profonda. L’Iran — o meglio, la Persia — non è soltanto un regime: è una civiltà viva, complessa, spirituale, che porta nel cuore contraddizioni e luci capaci di stupire persino l’osservatore più scettico.
Negli ultimi mesi, molti giornali europei hanno rilanciato accuse severe contro Teheran per la discriminazione delle minoranze curde e per la durezza delle autorità verso le donne iraniane che protestano per i diritti civili. Vicende tragiche e reali, come quella di Mahsa Amini, hanno lasciato un segno profondo nella coscienza collettiva. Ma la stessa stampa spesso dimentica di guardare anche ciò che resiste, ciò che nel tessuto sociale iraniano continua a parlare di dignità, di spiritualità e di fede popolare.
Perché accanto ai tribunali della morale e alla sorveglianza dei costumi, c’è un popolo che continua a pregare, e che spesso lo fa con un linguaggio di bellezza universale. Nelle stazioni della metropolitana di Teheran, ad esempio, c’è un mosaico che rappresenta la Vergine Maria, venerata come “Maryam”, la madre purissima del profeta Gesù. Non è un’eccezione folklorica: nell’Iran sciita, Maria è una figura di straordinaria devozione, un modello di purezza e di fede che attraversa i confini delle religioni. I musulmani iraniani le dedicano preghiere, poesie, e talvolta persino voti; il suo nome è tra i più diffusi nelle famiglie.
In una società rigidamente sorvegliata, quella immagine della Madonna nella metropolitana — posta in uno spazio quotidiano, pubblico, laico — dice qualcosa di più profondo: la fede semplice del popolo persiano non è stata spenta dal potere. È una fede che cerca la luce anche nei luoghi più impensati, che trova in Maria la donna della compassione, la madre del dolore condiviso, l’icona di una bellezza che nessun decreto può bandire.
L’Iran, del resto, non può essere letto solo con le lenti della politica. È una terra dove la poesia è ancora una forma di preghiera, dove la mistica di Hafez e Rumi convive con l’architettura islamica e i sussurri dei pellegrini di Qom. È un Paese che ha conosciuto repressione e orgoglio, isolamento e fierezza culturale, ma anche un’idea profonda di civiltà, che affonda le radici nella Persia zoroastriana e nell’universalismo dell’Islam sciita.
Il rapporto dell’Iran con le minoranze — in particolare con i curdi — resta problematico. I curdi iraniani, soprattutto nel nord-ovest, continuano a pagare un prezzo alto per la loro identità culturale e per le aspirazioni autonomiste. Le donne curde, poi, sono diventate simbolo di resistenza e vulnerabilità insieme: emarginate per doppia appartenenza, etnica e di genere, ma anche protagoniste coraggiose delle proteste civili. Tuttavia, non è tutto oppressione. Nelle regioni curde del Paese, le associazioni femminili islamiche locali hanno aperto scuole e centri di alfabetizzazione, segno che anche all’interno del sistema si muovono energie di cambiamento.
Una lettura equilibrata dell’Iran deve riconoscere questa coesistenza di ombra e luce: una teocrazia rigida, ma anche una società civile viva; un regime spesso chiuso, ma una cultura che respira libertà spirituale; una discriminazione reale, ma anche un patrimonio religioso capace di includere, nel cuore dell’Islam, una figura come la Madonna.
In questo senso, parlare dell’Iran oggi significa chiedersi se la speranza possa germogliare anche nei deserti della censura. L’immagine di Maria nella metro di Teheran è una risposta silenziosa: sì, può. È il segno che la grazia non si lascia sradicare dalle pietre, che il mistero del femminile sacro sopravvive a ogni regime, e che la cultura persiana — pur attraversata da tensioni e contraddizioni — continua a offrire al mondo un volto spirituale, capace di coniugare fede, bellezza e resistenza.
L’Iran non è solo un problema geopolitico: è una civiltà che prega, che conserva nei suoi templi e nei suoi cuori una nostalgia di luce. E forse proprio da quella piccola icona di Maria, nel frastuono della metropolitana di Teheran, potrebbe cominciare il dialogo più necessario: quello tra l’Islam e il mondo, tra la donna e il divino, tra l’Iran ferito e l’umanità che non ha smesso di sperare.