Meloni nega il fallimento del centro di rimpatrio in Albania
Ci sono idee politiche che nascono come spot, crescono come slogan e muoiono come conti. L’operazione dei rimpatri in Albania rientra perfettamente in questa genealogia: immaginata come la grande svolta, presentata come la soluzione che avrebbe riportato ordine nelle acque del Mediterraneo, si è trasformata in un gigantesco equivoco amministrativo, un sogno balcanico infranto sulle rive dell’Adriatico.
Il governo Meloni ne parla con la stessa passione con cui un illusionista difende il trucco che non è riuscito: non riconosce il flop, lo rilancia. E più la realtà lo smentisce, più lo si presenta come la prova che “bisogna insistere”. Una sorta di accanimento politico-terapeutico, in cui il paziente è ormai stremato — e il contribuente pure.
Perché, diciamolo: la narrazione era affascinante.
Un pezzo d’Italia in outsourcing, un avamposto oltreconfine dove trasferire l’intero capitolo migratorio, a metà tra il mito coloniale e il patriottismo amministrativo. Una specie di Ellis Island al contrario, dove però non si entra: si esce.
A guardarla bene, però, tutta l’operazione ricorda un vecchio mobile ingombrante che nessuno ha il coraggio di buttare: costa mantenerlo, è inutile, ma guai a dirlo. Per mesi se n’è parlato come dell’arma segreta che avrebbe rivoluzionato la gestione dei flussi; alla fine ci si è ritrovati con procedure più lente, costi più alti e un livello di efficienza che definire “modesto” è un omaggio alla diplomazia.
Nel frattempo, mentre la politica litiga su chi abbia avuto l’idea migliore o la sventura maggiore, resta un fatto incontestabile: il cittadino paga.
Paga strutture che funzionano a mezzo servizio, paga trasferimenti, paga logistica, paga protocolli bilaterali che sembrano scritti da un romanziere sperimentale. Paga soprattutto la distanza tra ciò che si promette e ciò che si ottiene.
Sullo sfondo c’è poi un’altra questione, più sottile e più seria: perché questa ostinazione? Perché trasformare un errore in una bandiera? Perché continuare a investire su qualcosa che, nei fatti, non decolla?
La risposta sta forse nel cuore simbolico della politica contemporanea: meglio difendere un mito che ammettere un limite.
Meglio parlare di “modello”, anche se non modella nulla, che riconoscere di aver confuso una mossa scenografica con una soluzione vera.
Eppure, basterebbe una dose di onestà intellettuale per togliere l’operazione dall’altare dei dogmi e riportarla nell’alveo delle idee sperimentate e poi archiviate. Ma nell’Italia del consenso istantaneo, abbandonare una promessa è più rischioso che mantenerla, anche quando mantenerla costa di più.
Così, mentre continuano i comunicati, i sorrisi di circostanza e le conferenze stampa rassicuranti, l’operazione Albania rimane quello che è: il monumento nazionale alla dissonanza cognitiva, l’emblema di un governo che non vuole vedere ciò che tutti vedono.
E forse è proprio per questo che il fallimento pesa più del progetto in sé: non perché non funzioni, ma perché dimostra qualcosa che nessuna maggioranza ama confessare.
Che la propaganda non è una politica.
E che l’Adriatico, per quanto lo si guardi con piglio fiero, non è un muro.
È un mare. E i mari, da sempre, preferiscono la verità alle scenografie.








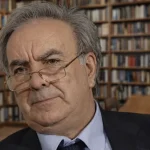





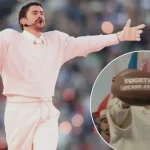




Ammazza che dislivello!