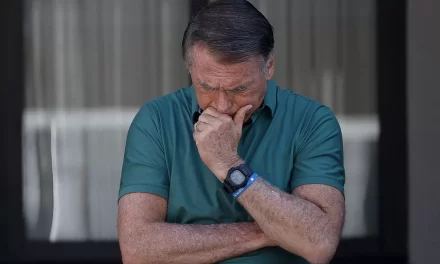Quando il potere passa dai pozzi di petrolio ai wafer di silicio, la geopolitica diventa una questione di coscienza. L’Europa deve decidere se restare mercato o tornare civiltà.
Quando nel Novecento si parlava di potere, si pensava al petrolio. Oggi il potere è fatto di silicio. Non alimenta motori, ma intelligenze: quelle artificiali, militari, digitali, economiche. Chi controlla i semiconduttori controlla i sistemi d’arma, le reti, i flussi di dati e, in definitiva, la sovranità tecnologica del mondo.
Taiwan è diventata il centro invisibile di questo nuovo impero. Produce oltre il 70% dei chip globali e quasi il 90% di quelli avanzati. La TSMC — Taiwan Semiconductor Manufacturing Company — è oggi per il pianeta ciò che fu la Royal Navy per l’Impero britannico: una potenza che non si vede, ma senza la quale nulla funziona. Solo che il suo dominio non si fonda su flotte e cannoni, ma su atomi di silicio, conoscenza e una rete logistica fragile e interdipendente.
Basterebbe una guerra, un blocco navale o un attacco informatico nello Stretto per paralizzare catene di approvvigionamento che toccano ogni cosa: dai telefoni ai satelliti, dalle auto ai respiratori ospedalieri. Ogni conflitto in Asia oggi avrebbe effetti planetari, spegnendo in pochi giorni il cuore tecnologico del mondo.
La Cina considera Taiwan parte del proprio territorio. Gli Stati Uniti la difendono come alleato di fatto. Ma entrambi, paradossalmente, sono ostaggi della stessa interdipendenza: Pechino non può conquistare ciò che distruggerebbe, e Washington non può abbandonare ciò da cui dipende la sua egemonia digitale. È una pace armata, una guerra sospesa, dove ogni esercitazione e ogni embargo diventano mosse di una partita che nessuno può davvero vincere. Dietro le tensioni del Mar Cinese Meridionale non si combatte solo per il territorio, ma per il cervello del mondo: il chip.
In questo scenario l’Europa appare vulnerabile e senza rotta. Ha eccellenze straordinarie — l’olandese ASML, che produce le macchine litografiche più sofisticate, e la franco-italiana STMicroelectronics, leader nei sensori — ma non controlla la produzione dei microprocessori. Costruisce i corpi delle sue tecnologie, ma importa il cervello.
Un’interruzione asiatica fermerebbe in poche settimane l’automotive, la sanità, la difesa e l’intero sistema industriale.
Il Chips Act europeo, con i suoi 43 miliardi, è un primo segnale politico ma non basta. L’Europa è ancora un insieme di economie coordinate, non una comunità strategica. Ogni Stato pensa alla propria filiera, e la sovranità tecnologica — che dovrebbe essere il fondamento del futuro — si disperde nei rivoli di nazionalismi economici.
Molti parlano di “decoupling”, di disaccoppiamento dalle catene asiatiche. Ma nel mondo globale la separazione è un’illusione. L’alternativa alla dipendenza non è l’autarchia, bensì la solidarietà strategica: una rete di alleanze tecnologiche tra democrazie, che condividano ricerca, etica e sicurezza.
L’Europa dovrebbe proporsi come un terzo polo del silicio, non per competere con Stati Uniti e Cina, ma per custodire un equilibrio tra potenza e libertà. Invece rischia di restare il grande supermercato dell’umanità: il mercato del mondo, ma non la sua mente. Eppure possiede le competenze e la cultura per un’altra via: legare l’innovazione alla dignità umana, la produttività alla responsabilità, la tecnica all’etica.
Perché il silicio non è neutrale. Ogni chip è una scelta morale: è il modo in cui decidiamo di estendere la nostra intelligenza nel mondo. Concentrare questa capacità in un solo punto geografico è un rischio antropologico, prima ancora che economico.
L’umanesimo cristiano ci ricorda che il potere non è dominio, ma servizio. Applicato alla tecnologia, significa che l’innovazione deve servire l’uomo, non sostituirlo.
Un’Europa che sappia tenere insieme sviluppo e umanità può diventare la voce che restituisce un’anima al capitalismo digitale, riportando la tecnica al suo fine originario: migliorare la vita, non controllarla.
Se Taiwan è oggi il Golgota del capitalismo digitale, il luogo in cui si decide il destino di tutti, l’Europa deve scegliere se restare spettatrice o protagonista.
Non basteranno investimenti o decreti: servirà un atto di fede politica, la convinzione che l’unità non è solo un ideale morale, ma una forza geopolitica.
Il vero bivio non è più tra Oriente e Occidente, ma tra una tecnologia senz’anima e una tecnologia con un volto umano.
Sovranità tecnologica significa custodire la libertà dell’uomo nell’epoca delle macchine.