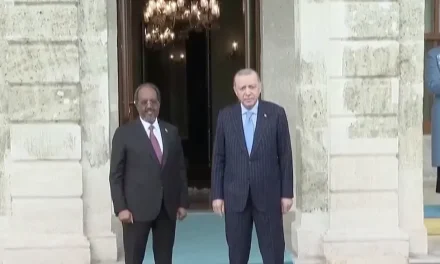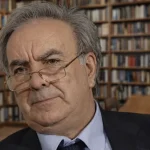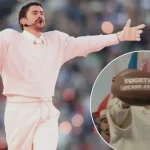Nicolas Sarkozy è tornato a casa, dopo tre settimane in una cella di La Santé che lui stesso ha definito “un incubo”. Ma l’eco del suo arresto, e del successivo rilascio, continua a scuotere la Francia più della sua porta di prigione che si chiude o si apre. Non è solo la vicenda di un ex capo di Stato sotto processo: è il riflesso di un Paese che da anni si interroga su dove finisca la giustizia e dove cominci la vendetta politica.
A settant’anni, l’uomo che guidò la Francia dal 2007 al 2012 non è nuovo alle aule giudiziarie. È già stato condannato per corruzione e finanziamento illecito di campagna elettorale, ma mai aveva conosciuto la prigione fisica — quella fatta di porte blindate, orari, silenzi. Per i suoi sostenitori, questo è stato un eccesso giudiziario; per i suoi detrattori, la prova che finalmente anche i potenti possono rispondere alla legge.
Il caso che lo perseguita da oltre un decennio riguarda presunti finanziamenti provenienti dal regime libico di Muammar Gheddafi per la campagna presidenziale del 2007. Sarkozy nega tutto: «Non confesserò mai qualcosa che non ho fatto», ha detto in un videomessaggio dalla cella. Parole che risuonano come un manifesto personale, ma anche come l’ennesimo atto di sfida a un sistema giudiziario che lui ritiene politicizzato.
La sua liberazione, accompagnata dalla mano della moglie Carla Bruni e dal sorriso stanco del figlio Louis, è diventata l’immagine di una Francia divisa. Da un lato chi lo considera un martire, simbolo di una destra perseguitata da magistrati ideologizzati; dall’altro chi vede in lui il volto della vecchia élite che, per troppo tempo, ha confuso il potere con l’impunità.
In mezzo, una questione più profonda: la giustizia, in democrazia, può permettersi di essere spettacolo?
L’arresto di un ex presidente è sempre un evento che scuote la memoria repubblicana, ma quando la punizione appare sproporzionata — come hanno riconosciuto anche osservatori moderati — il rischio è che il tribunale si trasformi in tribuna. La giustizia perde autorevolezza quando sembra voler dimostrare qualcosa più che giudicare qualcuno.
C’è poi l’aspetto umano, che Sarkozy stesso ha evocato: la durezza della detenzione, l’impatto psicologico di un isolamento che, per chi è stato abituato ai vertici del potere, è anche una caduta simbolica. “È stato un calvario, ma ho resistito”, ha detto. Ed è in questa frase che si legge il tratto più francese della sua parabola: l’orgoglio del combattente, il bisogno di rialzarsi per dimostrare che la storia non è finita.
La Francia, che in questi anni ha visto dissolversi i confini tra potere politico e giudiziario, esce da questa vicenda ancora più fragile. L’attuale governo Macron, già in bilico tra crisi di consenso e tensioni sociali, osserva con cautela. L’imbarazzo è evidente: il ministro dell’interno Gérald Darmanin — un tempo delfino di Sarkozy — ha persino ricevuto un divieto formale di incontrarlo. Un fatto inedito, che rivela la misura del disagio istituzionale.
Nel suo primo messaggio dopo la liberazione, Sarkozy ha scritto su X: «La verità prevarrà. La vita ce lo insegna sempre.» È una frase che suona come promessa e difesa insieme. Ma oltre le parole, resta un dato di fondo: la Francia non sa più se fidarsi dei suoi giudici, e i giudici non sanno più se possono giudicare i potenti senza essere accusati di fare politica.
L’ex presidente dovrà tornare in aula a marzo per un nuovo processo. La giustizia farà il suo corso, come sempre. Ma la vicenda di Nicolas Sarkozy – con le sue ombre, le sue ambiguità e la sua carica simbolica – resterà come una ferita aperta nella coscienza democratica francese: un monito, forse, che quando il potere e la giustizia smettono di parlarsi, è la verità a pagare il prezzo più alto.