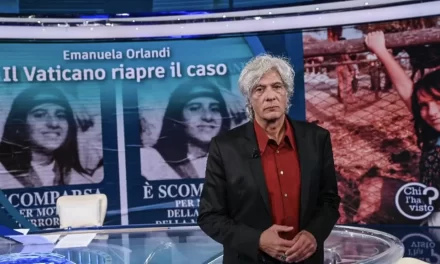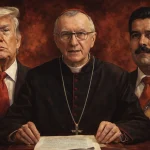Mentre il 2 novembre si avvicina e con esso il rinnovo automatico del Memorandum Italia-Libia, un nuovo dramma in mare riporta alla luce il prezzo umano di un accordo che da otto anni pesa come una colpa collettiva. Un peschereccio partito dalla Libia, con oltre cento persone a bordo, è arrivato a Pozzallo dopo essere stato attaccato dalla cosiddetta guardia costiera libica. Un ragazzo di quindici anni è in coma, colpito alla testa da un proiettile.
C’è un filo che unisce quella scena di violenza in mare ai documenti firmati nelle stanze dei governi europei. È il filo, sottile e crudele, che lega la politica alla vita concreta degli ultimi. L’Europa — e con essa l’Italia — continua a finanziare, addestrare e legittimare la cosiddetta guardia costiera libica, la stessa che spara contro chi fugge, che riporta nei centri di detenzione chi tenta di attraversare il Mediterraneo, che trasforma la speranza in prigionia.
Il Memorandum d’intesa, siglato nel 2017 dal governo italiano con l’allora premier libico Fayez al Sarraj, doveva servire a “contrastare l’immigrazione irregolare”. Ma col tempo si è rivelato uno strumento di delega alla violenza. Per otto anni, dietro la parola “cooperazione”, si è consumata una lunga abitudine alla complicità. Le nostre navi segnalano, i nostri fondi sostengono, i nostri silenzi coprono. Così, in nome della sicurezza, si è accettato che la frontiera diventasse una zona grigia dove il diritto internazionale si sospende e la dignità umana si perde.
Non si tratta solo di geopolitica. È una questione di coscienza. Ogni volta che una motovedetta libica, finanziata dall’Europa, intercetta un gommone e riporta indietro donne e bambini verso i centri di detenzione, siamo chiamati a chiederci: davvero questo è il prezzo della nostra tranquillità?
I rapporti internazionali, da anni, raccontano la stessa verità: torture, violenze sessuali, lavori forzati, estorsioni. Secondo l’Organizzazione Internazionale per le Migrazioni, dal 2017 ad oggi quasi 160 mila persone sono state intercettate e respinte in Libia. Migliaia risultano scomparse, altre vivono ancora nei lager. Non è un linguaggio ideologico, ma la cronaca quotidiana di un sistema disumano.
E mentre il Mediterraneo continua a restituire cadaveri, l’Europa discute “piani di rimpatrio volontario” e “nuove forme di cooperazione tecnica”. A Bruxelles, in questi giorni, si sono incontrate le delegazioni libiche — anche quelle del generale Haftar, non riconosciute a livello internazionale — per parlare di flussi e di numeri. Ma non di persone. Perché le persone disturbano, sporcano le statistiche, impongono un volto all’indifferenza.
In Italia, intanto, è tornato alla ribalta il caso Almasri, il torturatore libico accolto con un volo di Stato e poi rimpatriato, nonostante fosse ricercato dalla Corte penale internazionale. È un episodio che racconta più di tanti discorsi: l’abitudine a chiudere gli occhi, a giustificare tutto in nome della “ragion di Stato”. Ma la ragione, quando si stacca dall’etica, diventa solo cinismo.
In questi giorni, diverse organizzazioni e movimenti, tra cui Refugees in Libya, hanno rilanciato la campagna “Stop Memorandum”. Sono voci che vengono da chi quella realtà la vive sulla propria pelle: migranti e rifugiati che da Tripoli raccontano al mondo le violenze e le ingiustizie subite. Sono loro, oggi, a ricordarci che l’Europa non può essere fortezza ma ponte, non confine ma approdo.
Papa Francesco non smetteva di ripeterlo: “Il Mediterraneo non può diventare un cimitero.” Non è solo una denuncia, ma un invito a cambiare sguardo. A smettere di vedere nei migranti una minaccia e a riconoscere in loro fratelli e sorelle che bussano alla porta della nostra umanità.
Il 2 novembre, mentre l’Italia penserà ai suoi defunti, il Memorandum con la Libia verrà rinnovato in automatico. Forse è il momento di dire che non possiamo più accettarlo in silenzio. Perché la memoria dei morti del mare ci chiama alla responsabilità dei vivi.
Scegliere di non rinnovare quell’accordo non significa aprire indiscriminatamente le frontiere, ma riaffermare che nessuna politica può costruirsi sull’abuso, nessuna sicurezza può poggiare sull’ingiustizia. È un atto di coerenza con la nostra Costituzione, con la fede che proclamiamo e con il Vangelo che annuncia la dignità di ogni persona.
Siamo ancora in tempo per tornare umani.