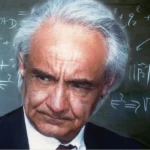Dal Super Bowl a Milano-Cortina, lo sport scopre che l’America non si divide solo sul voto: si divide sulle parole. Ma soprattutto, sotto il governo Trump, affiora un malessere generale che si misura in un fenomeno nuovo: chiunque abbia visibilità — artisti, atleti, celebrità, persino istituzioni sportive — finisce per esprimere dissenso, o comunque per prendere le distanze. Non sempre per vocazione politica, spesso per necessità: perché il clima è diventato così polarizzato che anche il silenzio viene interpretato come complicità. Trump attacca Bad Bunny per lo spagnolo e bolla “perdente” un atleta USA: ma tra piste e stadi riaffiora un’idea più difficile della propaganda — l’unità non è uniformità.
Dal Super Bowl 2026 a Milano-Cortina corre un filo teso: non la politica come tema, ma come atmosfera. Al Super Bowl la tensione è salita già nei giorni precedenti, quando dichiarazioni e voci sull’immigrazione hanno reso necessaria una presa di posizione della NFL: nessuna “attività ICE pianificata” attorno all’evento. Se una lega deve smentire la politica, vuol dire che lo stadio non è più solo stadio: è una piazza nazionale sotto pressione, e la paura — o il sospetto — diventa parte dello spettacolo.
Poi è arrivato l’halftime show e il punto è cambiato: non più “chi controlla”, ma “chi parla”. Bad Bunny ha portato sul palco il proprio immaginario latino-portoricano e lo ha fatto in spagnolo. Trump si è infuriato, trasformando la lingua in caso politico: non una critica musicale, ma un riflesso identitario. È in questi scatti che si legge il malessere: l’America che si riconosce plurale si sente messa sotto accusa; l’America che si sente assediata chiede un recinto. Quando una lingua diventa scandalo, la nazione smette di essere casa comune e rischia di diventare proprietà esclusiva.
La stessa logica riappare ai Giochi. Lo sciatore freestyle Hunter Hess ha detto che rappresentare gli USA gli suscita “emozioni miste”: amore per persone e valori, disagio per ciò che vede nel Paese. Trump lo ha definito un “perdente”. Anche qui il dissenso non viene registrato come fisiologia democratica, ma come offesa personale. E infatti il malessere collettivo si traduce in un automatismo: più il potere alza il tono, più chi è esposto pubblicamente sente il bisogno di marcare distanza. Hess ha replicato senza insultare: quando così tanti concittadini si sentono divisi, l’unità serve più che mai — non come slogan, ma come disciplina civile.
E poi Eileen Gu, l’icona globale di solito impermeabile alle polemiche: proprio a Milano-Cortina ha difeso l’idea che le Olimpiadi debbano restare “spazio sicuro”, l’ultimo luogo dove il mondo può incontrarsi senza trasformare tutto in trincea. Non è un manifesto: è un segnale. Se perfino chi vive di sponsor e silenzi calibrati sente il bisogno di dirlo, vuol dire che la frattura è visibile anche dalla pista — e che il disagio ha raggiunto persino chi, per professione, evita accuratamente le frasi “a rischio”.
Il punto, allora, non è “gli atleti devono fare politica” o “devono stare zitti”. Il punto è che oggi, dentro un malessere nazionale amplificato dal trumpismo, perfino la lingua e perfino la bandiera diventano test di appartenenza. E la parola “unità” è contesa: per alcuni è uniformità, per altri è convivenza. Dallo stadio alla neve, la domanda resta una sola: si può ancora stare insieme senza parlare tutti allo stesso modo, senza pensare tutti allo stesso modo?