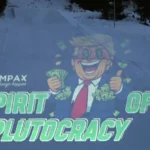Un’inchiesta internazionale ha portato alla luce un sistema di spionaggio digitale che attraversa continenti e governi. Dall’Indonesia all’Africa, passando per Israele, tecnologie nate per la sicurezza vengono usate per controllare giornalisti, oppositori e persino personalità pubbliche. È l’altra faccia della globalizzazione digitale: quella in cui il mercato corre più veloce della coscienza etica.
C’è un filo invisibile che lega un imprenditore israeliano residente in Uganda, un laboratorio informatico di Giacarta e le nuove guerre silenziose combattute nel mondo dei dati. È la trama – inquietante e verosimile – rivelata da un’indagine di Lighthouse Reports e Haaretz, insieme ad Amnesty International: la scoperta di una società indonesiana che fornisce strumenti di sorveglianza avanzata a governi e milizie, utilizzati per rintracciare giornalisti, critici politici e persino personalità del mondo dello spettacolo come Jared Leto.
Dietro la patina di tecnologia e progresso, si disegna una geografia dell’invisibile: server, software, “sonde” digitali capaci di intercettare comunicazioni e localizzare telefoni in tempo reale. Non si tratta di fantascienza, ma di un mercato parallelo – spesso legale sul piano formale – in cui la sicurezza diventa pretesto per la violazione sistematica dei diritti fondamentali.
Quando il controllo si traveste da protezione
Le democrazie stesse, spaventate dal terrorismo o dalla disinformazione, hanno progressivamente allargato il confine dell’accettabile. Ma nel Sud globale, dove le strutture di garanzia sono più fragili, questi strumenti diventano armi di repressione politica.
La società indonesiana sotto accusa, secondo l’inchiesta, ha fornito software e servizi a Stati africani dove la distinzione tra sicurezza e censura è ormai indistinta. E in questo intreccio, non mancano connessioni con operatori israeliani e con reti che orbitano intorno all’intelligence commerciale, ponte tra tecnologia occidentale e regimi autoritari.
Si crea così un paradosso morale: le stesse tecnologie nate in Paesi democratici per proteggere la libertà possono essere usate per distruggerla altrove. Il controllo si traveste da protezione, e il diritto alla privacy – pilastro della dignità umana – diventa una variabile negoziabile.
L’etica smarrita della tecnologia
Dietro ogni spyware, dietro ogni “metadato” raccolto senza consenso, c’è una domanda di fondo: chi controlla chi controlla?
Papa Francesco, nella Fratelli tutti, lo aveva previsto: «La tecnologia che libera può anche schiavizzare, se non è guidata da un’etica dell’uomo e per l’uomo». Oggi quelle parole trovano conferma in scenari dove la sorveglianza non è più monopolio degli Stati, ma un business globale.
Il rischio è la nascita di un nuovo colonialismo digitale, dove pochi detentori della tecnologia controllano molti che la subiscono.
La Chiesa, nel suo magistero sociale, richiama a una “governance etica dell’innovazione”: un’economia della tecnologia orientata al bene comune, non al profitto cieco. È un principio che non riguarda solo i governi, ma anche le aziende, i programmatori, gli utenti.
Ogni algoritmo, se privo di una coscienza morale, diventa un moltiplicatore di potere. E dove c’è potere senza responsabilità, la persona scompare.
L’urgenza di una coscienza globale
L’inchiesta non accusa solo un Paese o una compagnia: mette in questione il nostro modello di sviluppo digitale.
In una società che misura il valore dei dati più dell’uomo, la tentazione del controllo è irresistibile. Per questo servono non solo regole, ma una conversione dello sguardo.
La tecnologia non può sostituire la fiducia, né l’algoritmo può diventare il nuovo tribunale del comportamento umano.
Serve una cultura che unisca competenza e compassione, scienza e coscienza.
Perché l’innovazione, senza etica, non è progresso: è potere travestito da futuro.
Quella indonesiana non è solo una storia di spie e software. È un monito universale: la libertà, oggi, si difende anche nei circuiti di silicio.
E se il mondo digitale è diventato il nuovo spazio del potere, allora la fede, la filosofia e la società civile devono tornare a dirne il senso, non da spettatori ma da protagonisti.
Perché il vero progresso non è quello che sa tutto di noi, ma quello che ci aiuta a restare umani.