C’è una parabola politica che, più di altre, racconta il tempo inquieto del centrodestra italiano: quella di Roberto Vannacci, dalla clamorosa esposizione mediatica alla rottura con la Lega, fino alla scelta di mettersi in proprio creando il partito Futuro Nazionale. Una traiettoria rapida, rumorosa, eppure tutt’altro che improvvisata. Piuttosto, il prodotto di un calcolo che ha funzionato nel breve periodo e si è rivelato destabilizzante nel medio: usare l’eccesso per mobilitare consenso, salvo poi scoprire che l’eccesso non resta mai sotto controllo.
Matteo Salvini lo aveva capito prima di altri: alle elezioni europee servivano voti, visibilità, radicalità. Vannacci, con il suo linguaggio divisivo e la sua postura da “uomo contro”, garantiva entrambe le cose. La nomina a vicesegretario della Lega fu il sigillo politico di quell’operazione: un’investitura pensata per catturare un elettorato arrabbiato, identitario, insofferente a ogni mediazione. Ma come spesso accade, l’alleanza con l’ipersovranismo si è trasformata in un boomerang.
Perché Vannacci non è mai stato un “uomo di partito”. Né della Lega, né di alcun contenitore tradizionale. La sua forza – e il suo limite – è sempre stata l’idea di incarnare una verità alternativa, non negoziabile, che mal sopporta la disciplina e ancor meno la gradualità del potere. Così, dopo aver negato a lungo l’intenzione di fondare un proprio soggetto politico – esattamente come aveva negato di voler entrare stabilmente nella Lega – la rottura è diventata inevitabile. L’uscita dal partito di Salvini e la nascita di un movimento personale non sono state una sorpresa: sono state la logica conseguenza di un progetto che non poteva restare subordinato.
Un drenaggio silenzioso ma profondo
L’effetto più interessante non è tanto la sottrazione di qualche parlamentare – dinamica fisiologica in una fase di scomposizione – quanto il drenaggio elettorale. Vannacci pesca ovunque nel centrodestra: nella Lega, certo, ma forse ancor più in Fratelli d’Italia, intercettando un segmento di elettorato che considera Giorgia Meloni troppo istituzionale, troppo “di governo”, troppo prudente. È un voto che non chiede stabilità, ma riconoscimento identitario; non risultati, ma conflitto.
Qui sta il nodo politico: non è un’operazione a somma zero. Ogni voto che migra verso un sovranismo più estremo non rafforza il blocco conservatore nel suo insieme, lo frammenta. E la frammentazione, in un sistema democratico maturo, raramente premia chi governa.
Il rischio Zemmour, versione italiana
La traiettoria ricorda, con inquietante precisione, quanto accaduto in Francia con Éric Zemmour. Anche lì, un eccesso di radicalità ha prodotto visibilità, ha spostato l’asse del dibattito, ma alla fine ha allarmato l’elettorato moderato e contribuito a ricompattarlo contro l’ipotesi di una svolta autoritaria. Il sovranismo identitario, quando supera una certa soglia, smette di attrarre e comincia a spaventare.
Le parole contano. Parlare di “reimmigrazione” sul modello trumpiano, evocare visioni di società etnicamente e culturalmente omogenee, indulgere in un immaginario muscolare che guarda con nostalgia a simboli come la Decima MAS di Junio Valerio Borghese, non è semplice provocazione. È un messaggio politico che, in un Paese con una memoria storica ancora sensibile, attiva anticorpi profondi.
L’effetto sistemico: perdere vincendo
Il paradosso è tutto qui: Vannacci può crescere, anche sensibilmente, senza mai diventare decisivo per governare. Anzi, proprio la sua crescita rischia di essere la causa indiretta di una sconfitta del centrodestra nel suo complesso. Non perché sposti le masse a sinistra, ma perché incrina la fiducia di quell’elettorato di cerniera che teme l’instabilità, l’isolamento internazionale, la deriva autoritaria.
In questo senso, l’operazione Vannacci è una cartina di tornasole: misura quanto sia sottile la linea tra radicalità mobilitante e radicalità tossica. Salvini ha provato a cavalcarla per sopravvivere politicamente; Meloni la osserva con prudenza, consapevole che governare significa rassicurare, non eccitare.
Una destra davanti allo specchio
Alla fine, la questione non riguarda solo Vannacci. Riguarda la destra italiana nel suo insieme e la sua capacità di scegliere che cosa vuole essere: una forza di governo, capace di stare nei vincoli europei e democratici, oppure un arcipelago di identità urlate, ciascuna convinta di rappresentare il “vero popolo”.
La storia recente insegna che il sovranismo estremo può vincere battaglie culturali, ma perde spesso la guerra elettorale. E quando la politica flirta troppo a lungo con l’ombra dell’autoritarismo, non è solo l’avversario a mobilitarsi: è la società stessa che si ritrae.
Vannacci, forse, crescerà. Ma la domanda che il centrodestra dovrà porsi è più scomoda: quanto costa, in termini di futuro, ogni voto conquistato alimentando la paura?














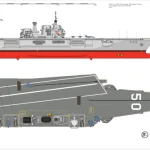




Abbiamo un nuovo “Figlio del secolo” o “l’uomo della provvidenza”?