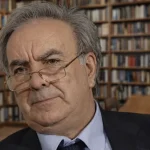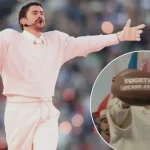A Pokrovsk, a metà novembre, il vento porta odore di fumo e terra bagnata. La città è quasi interamente circondata, e l’unica strada che ancora la collega al resto dell’Ucraina sembra più un atto di ostinazione che un corridoio logistico. I camion la imboccano di notte, luci spente, perché di giorno i droni russi pattugliano tutto. Eppure, continuano a passare.
Un soldato ucraino, in un video girato in fretta con un telefono che vibra per le esplosioni, dice una frase che resta addosso:
«Qui non c’è più una linea del fronte. Il fronte è ogni muro».
È questa la verità di Pokrovsk. Niente manovre eleganti, nessuna controffensiva brillante: solo avvicinamenti lenti, sfiancanti, che trasformano i quartieri in macerie e i sottoscala in trincee. La gente che è rimasta vive sottoterra, spostandosi da uno scantinato all’altro come se la superficie fosse diventata lunare.
La città — un tempo snodo ferroviario, luogo di passaggi, scambi, fabbriche — si è trasformata nella lente più spietata per osservare la guerra in atto. Qui non c’è propaganda che tenga: si vede tutto, nudo.
I militari parlano di Pokrovsk come di un “tappo”: se salta, l’acqua — cioè l’avanzata russa — scorre fino a Sloviansk e Kramatorsk. Ma non è solo una questione militare. È anche una questione psicologica: l’Ucraina ha già perso città importanti, ma Pokrovsk rappresenta l’idea che qualcosa possa ancora reggere.
Uno degli operatori umanitari rientrati da poco racconta che più che paura qui domina la stanchezza.
«Non si piange quasi più» dice. «Si osserva. Come se ognuno aspettasse di capire se deve scappare o restare. Ma non c’è più un luogo sicuro dove scappare».
Sul fronte russo la strategia è chiara: avanzare poco, avanzare sempre. Pokrovsk è l’esempio perfetto del metodo scelto da mesi. Consumare, erodere, stringere.
Non c’è fretta, solo un martello che colpisce allo stesso ritmo, giorno dopo giorno.
E intanto, dall’altra parte del continente, i governi discutono. Per l’Europa, per gli Stati Uniti, per tutti gli alleati di Kyiv, Pokrovsk è un termometro: se regge, si può ancora parlare di “resistenza efficace”; se cade, molti inizieranno a chiedersi se non sia il momento di rivedere il vocabolario politico della guerra.
La verità è che Pokrovsk mostra una cosa che nessuno vuole ammettere apertamente: questa guerra non la decidono le grandi conferenze, ma città come questa, di cui fino a due anni fa nessuno ricordava neppure il nome.
E mentre i diplomatici ragionano in termini di “fasi del conflitto”, a Pokrovsk un soldato guarda il fumo salire oltre la stazione e torna alla sua buca nel terreno.
Nella sua voce non c’è eroismo né rassegnazione. Solo realtà.
«Non so quanto dureremo», dice. «Ma finché c’è una strada, anche stretta, questa città respira. E noi con lei».
Ed è forse questa la cosa più importante: quella stretta strada che ancora resiste non è solo una via di rifornimento. È una metafora precisa.
Di una guerra che non finisce.
Di un Paese che non cede.
Di un’Europa che osserva — e un po’ teme — il momento in cui Pokrovsk non riuscirà più a respirare.