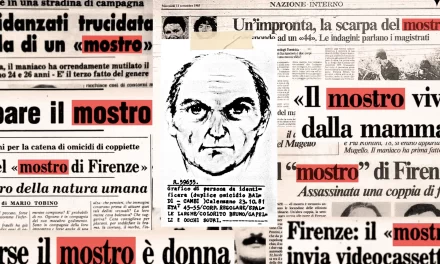Un’analisi sociale e psicologica sull’uso dei social da parte dei giovani
Non sono gli adolescenti – con i loro telefoni sempre in mano, i video, le storie e i like – a costituire il problema.
Sono il risultato di ciò che noi, adulti, abbiamo costruito intorno a loro: un mondo dove la connessione ha sostituito la presenza, dove l’efficienza conta più della parola, e dove anche l’affetto è spesso filtrato da uno schermo.
Quante volte, durante un pranzo di famiglia, ognuno di noi fissa il proprio smartphone invece di guardare negli occhi chi gli siede accanto? Quante riunioni, quante serate, quante vacanze sono ormai accompagnate più dalle notifiche che dalle conversazioni?
Prima di accusare i giovani di superficialità, dovremmo chiederci che tipo di modelli relazionali abbiamo saputo offrire.
Non solo superficialità
L’adolescente digitale, spesso liquidato come “alienato” o “dipendente”, è in realtà il frutto di una società che ha smarrito la lentezza del dialogo.
Ma, a ben vedere, i giovani non si limitano a subire le piattaforme: le usano per creare, per esprimersi, per costruire comunità.
Secondo i dati europei più recenti, sono proprio i giovani tra i 18 e i 30 anni a mostrare i livelli più alti di impegno sociale e volontariato. Sono anche i più attivi nello sport, nella musica, nel volontariato culturale, nella cooperazione internazionale.
In altre parole: mentre gli adulti parlano di “crisi dei valori”, molti ragazzi li mettono in pratica — anche attraverso i nuovi strumenti digitali.
Certo, i social network sono spazi ambigui, dove libertà e dipendenza si sfiorano. Ma sono anche laboratori di relazione, in cui i giovani allenano creatività, spirito critico e capacità di espressione. E, paradossalmente, cercano proprio lì ciò che spesso non trovano “in real life”: ascolto, riconoscimento, parola.
La scuola, grande assente del dialogo
Persino nei luoghi dell’educazione, i ragazzi non hanno voce.
La scuola resta spesso verticale: il docente parla, l’alunno ascolta. Tutto è predefinito, poco è co-costruito.
Eppure, la sociabilità non nasce dall’obbedienza, ma dall’esperienza della parola condivisa.
Imparare a discutere, a dissentire senza distruggere, a cooperare — richiede tempo, spazi, fiducia.
Invece, gli insegnanti corrono per “finire il programma”, compressi in un calendario che lascia poco spazio alla conversazione vera, alla costruzione di un pensiero relazionale.
Riscoprire il valore della parola, nella scuola come nella famiglia, significherebbe ridare ai giovani la possibilità di sentirsi protagonisti di un discorso comune, non solo destinatari di messaggi.
Una società del legame, non della performance
Forse il punto non è come “proteggere” i giovani dai social, ma come ricostruire attorno a loro un tessuto di relazioni umane autentiche.
Questo chiede un lavoro profondo sulle strutture della vita quotidiana: tempi familiari più distesi, politiche sociali che sostengano la genitorialità, luoghi di incontro non commerciali dove imparare ad ascoltarsi.
L’educazione al dialogo non è un’abilità accessoria, ma un pilastro della democrazia.
E richiede adulti capaci di ascolto, educatori formati alla cooperazione, una cultura collettiva che valorizzi la conversazione come forma di conoscenza e di cura.
Non temere i giovani: seguirli per imparare
I giovani non sono in fuga dalla realtà: cercano una realtà abitabile.
Dietro il rumore dei social, si nasconde spesso una sete di senso.
E se talvolta i loro mezzi di comunicazione ci appaiono estranei, è solo perché non parliamo più la lingua della relazione.
Forse dovremmo smettere di chiedere ai giovani di “disconnettersi” e iniziare noi adulti a riconneterci al loro mondo, alle loro domande, alle loro passioni, al loro modo nuovo – e spesso sincero – di cercare il bene.
Perché la società del futuro non nascerà dal silenzio delle generazioni, ma da una conversazione ritrovata.