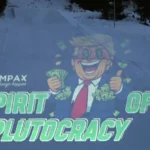C’è qualcosa di profondamente simbolico nell’arresto di Greta Thunberg a Londra, durante una manifestazione pro-Palestina, e nel suo rilascio su cauzione poche ore dopo. Non è solo l’ennesimo episodio di cronaca giudiziaria che coinvolge l’attivista più famosa della sua generazione. È piuttosto una cartina di tornasole del cortocircuito morale e politico in cui si muove oggi l’Occidente, incapace di distinguere tra dissenso, disobbedienza civile e radicalizzazione simbolica.
Greta non è nuova a gesti che forzano il confine tra testimonianza e provocazione. Ma qui il punto non è la sua biografia militante. Il punto è il contesto: una democrazia liberale che, nel nome della sicurezza e della legislazione antiterrorismo, arriva a fermare una ventiduenne per un cartello. E, specularmente, un’attivista che assume un linguaggio assoluto — «mi oppongo al genocidio» — in un conflitto che per sua natura rifiuta le semplificazioni morali.
La manifestazione era stata organizzata per sostenere otto detenuti del gruppo Palestine Action, in sciopero della fame da oltre cinquanta giorni. Il governo britannico guidato da Keir Starmer ha messo al bando l’organizzazione come “terrorista”, scelta che ha spaccato l’opinione pubblica e attirato critiche da ong, ambienti pacifisti e agenzie internazionali. La polizia ha applicato l’articolo 13 del Terrorism Act: esporre simboli o messaggi a sostegno di un gruppo vietato diventa reato. La legge è chiara. Il problema è politico e culturale.
Qui emerge la prima frattura: l’uso di strumenti eccezionali — pensati per contrastare il terrorismo armato — contro forme di protesta che, per quanto radicali e talvolta discutibili, non hanno mai colpito persone. Il parallelo evocato con Bobby Sands e lo sciopero della fame del 1981 è forte, forse eccessivo, ma rivela una percezione diffusa: lo Stato appare sordo, burocratico, impermeabile a ogni mediazione. E quando lo Stato non ascolta, la protesta si fa assoluta.
La seconda frattura è nel linguaggio. Greta parla di “genocidio” con la stessa nettezza con cui un tempo parlava di “estinzione climatica”. È la cifra della sua generazione: categorie totali, giudizi morali non negoziabili, rifiuto delle zone grigie. Ma la politica internazionale — soprattutto in Medio Oriente — vive di tragiche ambiguità, responsabilità intrecciate, colpe distribuite. Trasformare tutto in un aut-aut morale non aiuta le vittime, né avvicina la pace.
Eppure, fermare Greta non rafforza la democrazia. La indebolisce. Perché la sua figura funziona come uno specchio impietoso: ogni arresto la trasforma, agli occhi dei suoi sostenitori, in martire civile; ogni rilascio conferma l’impressione di un potere che non sa più come gestire il dissenso se non con il codice penale.
Alla fine, l’episodio londinese dice più di quanto sembri. Dice di un’Europa che predica diritti e libertà ma reagisce in modo difensivo quando questi diritti diventano scomodi. Dice di una protesta che, perdendo il senso della misura, rischia di trasformarsi in gesto performativo, più attento all’impatto simbolico che alla costruzione di soluzioni. E dice di una generazione che non accetta più mediazioni, perché non si fida più delle istituzioni.
Greta Thunberg è stata arrestata e rilasciata. Domani sarà di nuovo in piazza, o sui social, o in qualche aula di tribunale. Il problema non è lei. Il problema è un Occidente che non sa più rispondere alle domande radicali se non oscillando tra repressione e indulgenza. E quando accade questo, la politica abdica, lasciando il campo alla protesta assoluta — e alla legge penale come unico linguaggio rimasto.