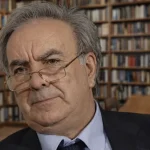Ad Addis Abeba, davanti ai leader dei 55 Paesi dell’Unione Africana, Giorgia Meloni prova a trasformare l’Italia nel perno europeo del rapporto con il continente: difende il Piano Mattei, promette formazione e investimenti (anche sull’AI) e lega il futuro di Roma e Bruxelles alla stabilità africana. Ma tra guerre aperte, debito soffocante e fame di energia, la domanda che rimbalza nel summit è una sola: la spinta italiana saprà tradursi in risultati concreti per l’Africa, oltre gli slogan?
Addis Abeba, febbraio 2026: l’Africa si guarda allo specchio e non vede una sola immagine. Vede un continente che, lentamente, comincia a somigliare alla promessa che da decenni le viene attribuita; e insieme vede le sue cicatrici – guerre, debito, energia, acqua – che non sono “emergenze”, ma strutture. Per questo, quando si chiude la 39ª Assemblea dell’Unione Africana, la parola che ricorre non è “miracolo”, né “boom”, ma pace: non un ideale, bensì la condizione minima per evitare che ogni crescita resti un fuoco di paglia.
I numeri, del resto, hanno il fascino delle svolte: diverse proiezioni indicano per il 2026 un’accelerazione africana capace perfino di avvicinarsi o superare – in media – il ritmo asiatico, un’inversione simbolica che dice molto più di un grafico. Ma è proprio qui che l’Assemblea suona come un controcanto: la crescita non è un destino, è una scelta politica; e senza sicurezza, istituzioni e accesso ai servizi essenziali resta una cifra che si scrive bene nei report e male negli ospedali di provincia.
È dentro questa tensione che Giorgia Meloni, invitata d’onore, porta il suo messaggio: l’Italia e l’Europa – dice in sostanza – non possono pensare il proprio futuro senza l’Africa; e insiste sui progetti di formazione dei giovani, persino nell’intelligenza artificiale, come segno di una cooperazione che vorrebbe spostarsi dall’assistenza alla capacità. Il lessico è quello della reciprocità (“il nostro futuro dipende dal vostro”), e l’operazione è evidente: far diventare il Piano Mattei il nome italiano di una nuova postura europea, meno predicatoria e più contrattuale.
Eppure, ad Addis Abeba, il Piano Mattei si percepisce anche come un test: non solo di risorse, ma di ascolto. Il governo italiano lo presenta come un dispositivo ormai “operativo e strutturato”, con progetti in 14 Paesi e l’intenzione di allargarne la platea nel 2026. Ma la domanda africana – quella reale, spesso non detta nei discorsi ufficiali – è più spigolosa: che cosa cambia davvero nella catena del valore? chi decide? chi controlla? chi resta con le infrastrutture quando le telecamere si spengono?
Questa è la contraddizione che affiora tra le righe dell’Assemblea: l’Africa possiede “vecchie” urgenze che non invecchiano mai (pace, acqua, energia, lavoro), ma anche “nuove” priorità che crescono con la demografia e l’urbanizzazione. Un presidente come Évariste Ndayishimiye (Burundi) lo mette in forma netta: il dividendo demografico può essere una forza o un rischio, dipende da istruzione, formazione, ricerca e accesso al lavoro. È una frase che suona semplice, ma ha la struttura di un ultimatum: o trasformi la gioventù in capitale umano, o la gioventù diventa frattura sociale.
E qui entra il tema più imbarazzante: la leadership. L’Africa giovane è spesso governata da classi dirigenti anziane, e non è solo un problema anagrafico. È un problema di immaginazione politica: come costruisci politiche pubbliche per società connessissime, mobili, affamate di opportunità, se pensi ancora in categorie da Stato post-coloniale novecentesco? Addis Abeba non lo dice con brutalità, ma lo lascia intuire: la distanza tra energia sociale e inerzia istituzionale è il vero conflitto sotterraneo del continente.
Poi c’è la pace: Mahmoud Ali Youssouf, presidente della Commissione UA, elenca i teatri che bruciano – Sudan, Sahel, RDC orientale, Somalia – come se stesse recitando un rosario tragico, e non è retorica: è l’infrastruttura negativa che divora bilanci, sposta persone, spegne investimenti. E il Medio Oriente entra nel discorso africano non come “tema esterno”, ma come ferita globale: la Palestina, la sofferenza del suo popolo, l’appello a fermare lo sterminio. Addis Abeba, in questo senso, si comporta da soggetto politico: non vuole più essere il luogo dove si subiscono le decisioni altrui.
Ma la pace, da sola, non basta a cambiare traiettoria se il continente resta intrappolato nel meccanismo più antico e più moderno insieme: il debito. António Guterres lo dice con la chiarezza dei numeri: i Paesi africani pagano interessi fino a otto volte più alti delle economie avanzate; così si strangola l’investimento prima ancora che nasca. E allora la “riforma dell’architettura finanziaria internazionale” non è un titolo da seminario ONU: è la condizione per passare dalla crescita “stimata” alla crescita “abitata”. Non sorprende che Meloni, nel suo vertice Italia-Africa, abbia inserito anche l’idea di clausole di sospensione del debito in caso di shock climatici: è un tentativo di mettere un pezzo di realismo dentro una finanza che, oggi, chiede al Sud globale di pagare il rischio del mondo due volte.
Poi, inevitabile, arriva l’energia: l’Africa riceve ancora una quota minima degli investimenti globali in energia pulita, e qui la partita non è “ambientalista” ma industriale. Se l’energia manca, la manifattura resta un sogno; se la rete elettrica non regge, anche l’innovazione digitale resta un poster. Ecco perché il Piano Mattei, se vuole essere più di uno slogan, deve dimostrare di saper stare su questo crinale: sviluppo reale, non solo controllo dei flussi migratori; partenariati che non odorino di convocazione “paese-continente”, ma di co-progettazione.
La verità è che ad Addis Abeba non si è discusso soltanto di Africa. Si è discusso del futuro europeo, visto dal suo punto più sincero: il confine sud. L’Italia prova a presentarsi come ponte; l’Africa, però, non chiede ponti per attraversare, chiede strade per restare. E in questo scambio – pace come pre-condizione, finanza come leva, energia come fondamento, giovani come orologio del tempo storico – si misura la credibilità di ogni piano, Mattei incluso.
Perché la Storia, sì, sembra correre. Ma correre dove? Se corre verso un’Africa che finalmente capitalizza la propria crescita e la propria demografia, allora Addis Abeba 2026 sarà ricordata come un passaggio. Se corre verso l’ennesima stagione di promesse, in cui i progetti arrivano e ripartono mentre i tassi d’interesse restano “otto volte”, allora sarà stata solo un’altra assemblea con belle parole e poche condotte d’acqua.
L’Africa, oggi, non chiede applausi. Chiede tempo lungo, condizioni e rispetto. E soprattutto chiede che la pace – l’“eterna assente” – smetta di essere la frase iniziale di ogni discorso e diventi la prima infrastruttura del suo sviluppo.