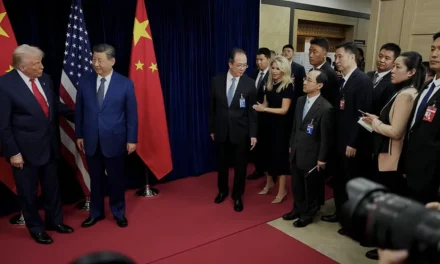Un tempo la parola “inferno” era relegata alla condizione eterna degli uomini cattivi e dei diavoli. Oggi basta accendere i telegiornali e guardare i video che arrivano da Gaza City all’alba: colonne di famiglie che fuggono tra le macerie, bambini piangenti portati a braccia, anziani trascinati su carretti, palazzi che crollano come castelli di carta. È questa l’immagine dell’inferno sulla terra.
Israele ha scelto l’assalto totale, parlando di “colpire il cuore del terrorismo”. Ma i numeri raccontano altro: decine di morti ogni notte, corpi di bambini mutilati con arti e teste mozzate e, quando va bene, insanguinati e portati negli ospedali. Interi quartieri rasi al suolo. La Commissione d’inchiesta indipendente dell’Onu parla senza esitazione di atti che rientrano nella definizione di genocidio. Da Tel Aviv si respinge indignati, ma davanti agli occhi del mondo si consuma una distruzione sistematica che va ben oltre l’eliminazione di Hamas: riguarda un popolo intero, costretto a fuggire e rifuggire, fino a perdere anche l’istinto primordiale della sopravvivenza.
Le immagini della marcia di 300mila sfollati verso il sud della Striscia ricordano altre colonne di disperati nella storia europea o degli Armani. E non si può non pensare alla sorte degli ebrei nei ghetti degli anni ’40. Con una differenza dolorosa: allora i nazisti perseguitavano e deportavano, ma non cancellavano intere città per sostituire una popolazione con un’altra. Qui, invece, la devastazione urbana e l’esodo forzato sembrano essere parte di un progetto di ingegneria e architettura.
Dentro Gaza resta chi non ce la fa ad andare via: malati, vecchi, madri che non vogliono abbandonare i figli sepolti sotto le macerie. Cosa ne sarà di loro? Saranno colpiti ancora, in nome della “lotta al terrorismo”? Si può davvero credere che un intero popolo sia ridotto a scudo umano?
Da Roma a Washington si moltiplicano gli appelli al cessate il fuoco. Ma accanto alle parole diplomatiche ci sono gesti che bruciano: il pollice alzato in segno di vittoria del segretario di Stato Usa all’uscita da Tel Aviv stride con il pianto di chi ha perso tutto. Come se la politica internazionale fosse un videogioco, mentre sotto le bombe si consuma la tragedia di centinaia di migliaia di innocenti.
Eppure, in mezzo a questo abisso, ci sono segni che interrogano. A Gaza, nella parrocchia della Sacra Famiglia, padre Gabriel Romanelli continua a distribuire cibo e medicine a 450 rifugiati, a tenere aperta una farmacia, a cantare lo Stabat Mater tra le bombe. È il dolore di Maria sotto la Croce, che diventa compassione concreta. È un lampo di Vangelo dentro l’inferno.
La domanda rimane: quanto ancora? Quante altre colonne di profughi, quanti altri bambini insanguinati dovremo vedere prima che il mondo si scuota davvero? Possiamo discutere di definizioni legali, di equilibri geopolitici, di strategie militari. Ma la realtà di Gaza non ha bisogno di aggettivi: basta guardarla. E chi guarda, se ha ancora cuore, non può che gridare: fermatevi.