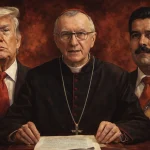C’è un momento in cui la politica estera diventa teatro d’ombre: si muovono navi vere, ma per mandare segnali, non per incidere. L’invio (e contro-invio) della fregata Virginio Fasan per “assistere” la Global Sumud Flotilla diretta verso Gaza è esattamente questo: una mossa di immagine, non di strategia. Lo ammettono, tra le righe, gli stessi vertici: scorta vera non ce n’è, regole d’ingaggio ridotte al minimo, distanza di sicurezza e, soprattutto, nessuna intenzione di misurarsi con il nodo politico — il blocco navale israeliano e il mancato riconoscimento dello Stato di Palestina.
La narrazione ufficiale è la solita: “tuteliamo i nostri connazionali”. E però, quando si scava, emergono i limiti scelti a tavolino: la Fasan (o la sua sostituta, la Alpino) non scorterà il convoglio, resterà fuori da acque dove altri Stati hanno giurisdizione primaria, controllerà “a distanza” e, in ogni caso, non forzerà alcun blocco. È assistenza “umanitaria” a geometria variabile: abbastanza visibile per placare l’opinione pubblica, abbastanza innocua da non irritare Gerusalemme. Nel frattempo, anche la Spagna invia un’unità — la nave d’azione marittima Furor — rivendicando apertamente il carattere umanitario e non minaccioso della Flotilla. Due linee: Madrid parla, Roma esita.
Il punto politico, infatti, non è nautico: è morale e giuridico. Da mesi l’Italia si arrampica sugli specchi per giustificare l’inerzia sul riconoscimento della Palestina, pur nel vortice di vittime civili e distruzione a Gaza. Quando la premier rovescia l’onere sulle piazze accusandole di “creare problemi di ordine pubblico”, abdica al proprio ruolo: in democrazia le piazze non sostituiscono la politica estera, la sollecitano. E la diplomazia, se è tale, si misura sul terreno duro dei negoziati, delle pressioni coordinate con partner europei, di condizionalità chiare sull’uso della forza, non su una cartolina navale. Intanto l’Alto Commissariato ONU per i Diritti Umani ha chiesto un’inchiesta indipendente sui ripetuti attacchi e le intimidazioni contro la Flotilla: non bastano più i comunicati, servono atti.
Qualcuno obietterà: “Che cosa dovremmo fare, dichiarare guerra a Israele?”. È la falsa alternativa che sterilizza ogni dibattito serio. In mezzo tra l’applauso pavloviano e il gesto bellico c’è un ventaglio di scelte molto concrete:
- Riconoscimento bilanciato dello Stato di Palestina, coordinato con partner UE, come leva per riaprire un processo politico reale, e non come bandierina identitaria.
- Condizionalità su export e cooperazioni militari quando esistono seri dubbi di violazioni del diritto internazionale umanitario.
- Corridoi umanitari verificabili (anche marittimi) con meccanismi terzi di ispezione e consegna, coinvolgendo Santa Sede, Mezzaluna Rossa/CRI e attori neutrali.
- Trasparenza sugli episodi in mare: black box obbligatorie, condivisione dati e inchieste congiunte quando si verificano attacchi a convogli civili.
Questa è politica estera responsabile: non “dichiarare guerra”, ma dichiarare principi e difenderli con strumenti legali e multilaterali.
In controluce, la vicenda Flotilla rivela altro: l’Europa si sta muovendo, seppur in ordine sparso. Il fatto che Madridmetta la faccia — con toni esplicitamente politici oltre che umanitari — indica che lo spazio per una linea europea autonoma c’è. Roma, al contrario, appare inchiodata al pilota automatico: non rompere con Israele, non scontentare Washington, rassicurare le piazze con una nave “che c’è ma non si vede”. È gestione del consenso, non visione.
Infine, una parola sulla Flotilla. Si può discutere l’opportunità di sfidare un blocco contestato da anni e difeso con gli argomenti securitari. Ma non si discute il diritto dei civili a non essere attaccati e a portare aiuti: se ci sono accuse di droni, stordenti e intimidazioni, si indaga — seriamente, non a colpi di smentite. E se davvero la missione è “solo immagine”, sia per gli attivisti sia per i governi, c’è un modo per smascherarla: aprire corridoi efficaci e tracciabili che tolgano alibi a tutti. Altrimenti continueremo con la politica degli specchi: vediamo ciò che vogliamo vedere e fingiamo che basti.
Oggi l’Italia ha un’occasione semplice e difficile insieme: passare dalla nave al negoziato, dall’icona alla sostanza. Non serve una fregata in più. Serve una posizione.