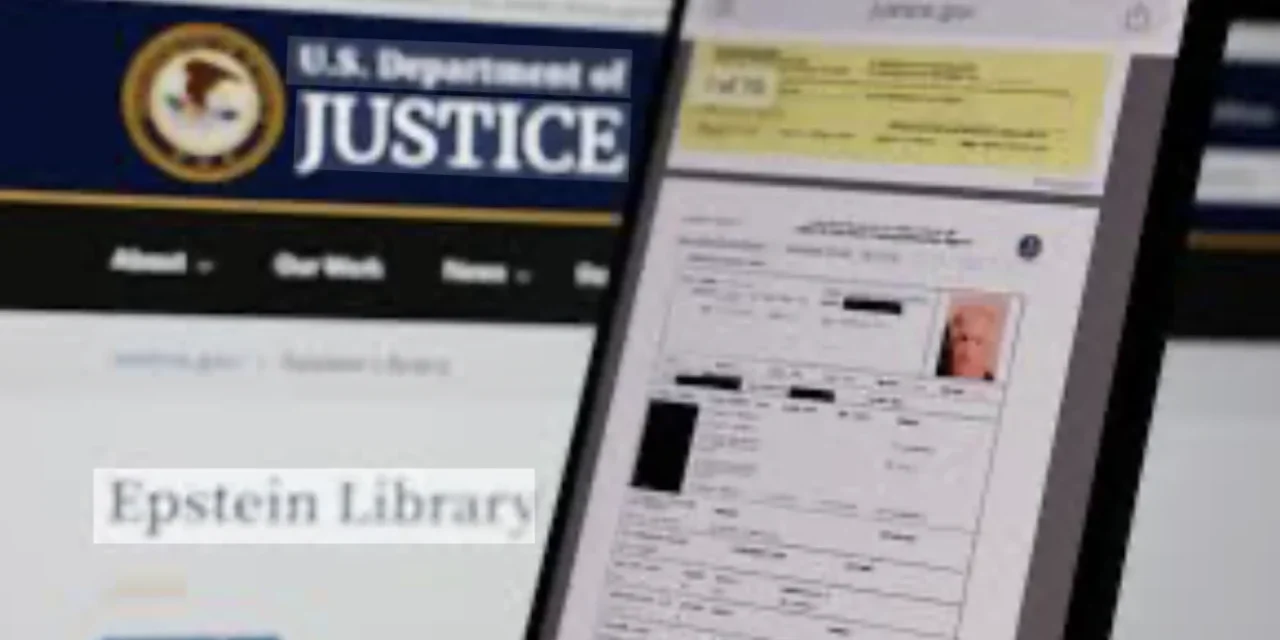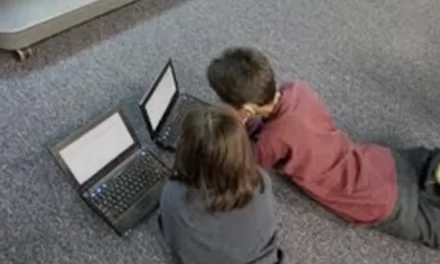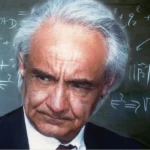L’eccesso di file immessi per il caso Epstein diventa cortina fumogena alla verità
C’è un equivoco moderno – figlio della cultura digitale e della sua retorica morale – secondo cui più documenti equivalgono a più verità. È un’idea seducente, quasi liturgica: si “scaricano” milioni di file e si pronuncia la formula magica della trasparenza. Ma la verità, come la giustizia, non vive di quantità: vive di ordine, contesto, verificabilità, completezza. E soprattutto vive di una domanda non negoziabile: chi decide cosa si vede e cosa no?
Nel caso Epstein, l’operazione di “apertura” dei dossier somiglia troppo spesso a una manovra doppia: da un lato l’overload informativo – la valanga di materiali che schiaccia la capacità pubblica di discernere – e dall’altro la notizia, più corrosiva, della selezione, delle parti oscurate, dei pezzi mancanti. È qui che la “trasparenza” si rovescia nel suo contrario: non una finestra, ma una cortina fumogena. Un eccesso controllato che produce caos; un caos utile perché, dentro il rumore, i nomi davvero sensibili possono rimanere indistinti, o essere confusi tra mille piste secondarie.
Il meccanismo è noto a chi studia la comunicazione del potere: quando non puoi negare l’esistenza di un fatto, lo sommergi. Non lo cancelli: lo rendi illeggibile. È una tecnica antica, aggiornata al linguaggio dei server. Nel Novecento si parlava di “depistaggio”; oggi si può chiamare, con un sorriso amaro, “open data”. Ma l’effetto è lo stesso: l’opinione pubblica viene invitata a fare ciò che non può fare – setacciare tutto – e, fallendo, si convince che la verità non esista, o che sia comunque irraggiungibile. È il trionfo della rassegnazione informativa: se tutto è scandaloso, nulla lo è davvero.
E intanto, mentre i giornalisti scandagliano e-mail e agende e scambi di favori, emerge un teatro psicologico sconcertante: il sussurro collettivo del “come hanno potuto?” rivolto a luminari, professori, filantropi, ex funzionari, pezzi di establishment. Ma a leggere ravvicinatamente la trama epistolare – fatta di inviti, introduzioni, “dove sei?”, “passo in città”, “brainstorming”, favori travestiti da conversazioni – quel “come” diventa meno misterioso. Epstein non era un genio metafisico della seduzione: era un conoscitore del punto cieco dell’élite.
Quando un uomo marchiato da una condanna cercava riabilitazione, sapeva dove bussare: presso una classe dirigente addestrata – per cultura, per convenienza, talvolta per cinismo – a distogliere lo sguardo. Non necessariamente perché complice di reati, ma perché educata a relativizzare il dolore altrui, a metabolizzare l’inaccettabile come “costo del sistema”, a separare la morale dalla carriera, la coscienza dall’opportunità, l’umano dall’utile. Il vero cemento di quella rete non è un’ideologia comune: è una solidarietà orizzontale, di ceto, che spesso conta più del bene comune.
È qui che il caso Epstein smette di essere solo cronaca nera e diventa anatomia sociale: non solo la storia di un predatore e delle sue vittime – che restano il centro morale della vicenda, e guai a spostarlo – ma anche la storia di un ordine reputazionale che sa perdonare in alto ciò che condanna in basso. Le “seconde possibilità” infinite per chi appartiene al circuito; le “prime possibilità” negate a chi sta fuori. La percezione popolare di una “classe Epstein”, al netto di ogni semplificazione, intercetta un nervo scoperto: l’esistenza di una meritocrazia privata e autoreferenziale che attraversa politica, finanza, accademia, filantropia, media, consulenza. Un arcipelago di potere che si riproduce scambiando capitali diversi: denaro in prestigio, prestigio in accesso, accesso in protezione.
Dentro questo quadro, l’overload informativo è perfetto: alimenta la caccia ai nomi come sport nazionale, produce una sequenza infinita di “cadute” – un luminare adulante dopo l’altro – e intanto sposta il fuoco: dal nodo strutturale (come funziona questa rete) al teatro enumerativo (quanti sono, chi c’è, chi manca). È la differenza tra capire un sistema e consumare una lista. E le liste, si sa, sono manipolabili: basta una censura mirata, una sforbiciata su snodi decisivi, e il pubblico viene lasciato con una narrazione che “sembra completa” proprio perché è enorme.
A questo punto entra il tema più delicato: l’imbarazzo dei potenti, a partire da Donald Trump e di altri che, per ragioni diverse, non hanno interesse a una ricostruzione limpida e lineare. Non serve insinuare ciò che non si può provare; basta osservare la logica politica. Chiunque abbia una vulnerabilità – un legame, un’amicizia, un favore, una fotografia, un contatto, un invito – ha convenienza a una verità spalmata, mai focalizzata. La nebbia, in politica, è spesso più utile della menzogna: perché la menzogna può essere smentita; la nebbia no. La nebbia si abita.
Ecco perché, da medillogo, l’argomento non è moralistico ma tecnico: l’eccesso di file e la presenza di parti oscurate producono un ecosistema narrativo in cui prosperano due estremi ugualmente sterili. Da un lato il complottismo totale (“tutti colpevoli, tutto orchestrato”), dall’altro lo scetticismo cinico (“non sapremo mai nulla”). In mezzo, la fatica del giornalismo vero: quello che non si ubriaca dell’archivio, ma pretende criteri, catene di custodia, versioni integrali verificabili, tempi, responsabilità, e soprattutto la capacità di rimettere al centro ciò che l’overload tende a cancellare: le vittime e la domanda di giustizia.
La trasparenza non è un diluvio. È un’architettura.
Se la “pubblicazione” diventa una discarica e la censura diventa un’ombra permanente, allora la verità non avanza: arretra. E chi non vuole apparire – chiunque esso sia, potente o potente per prossimità – ringrazia. Perché nel frastuono, ciò che conta davvero non è ciò che emerge: è ciò che non si riesce più a distinguere.