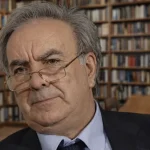C’è un luogo, nella guerra, dove il dolore non fa rumore. Non esplode, non lampeggia nei titoli, non entra nelle mappe strategiche. È il corpo delle donne. A Gaza, oggi, essere donna significa abitare questo silenzio: un silenzio fatto di fame trattenuta, di sangue nascosto, di paura che non chiede permesso.
Le donne di Gaza non combattono. Resistono. Resistono cancellandosi. Mangiano meno per nutrire i figli. Dormono poco per vegliare sul freddo che potrebbe portare via un neonato. Rinunciano alla privacy, alla dignità, persino al dolore, perché il dolore – in guerra – è un lusso che non ci si può permettere.
La guerra entra così nel corpo femminile come una seconda pelle. Ogni ciclo mestruale diventa un problema logistico. Ogni gravidanza una scommessa sulla vita. Ogni parto un atto di coraggio primordiale, spesso senza anestesia, senza una stanza, senza silenzio. Le urla delle donne che partoriscono a Gaza non sono solo grida di dolore: sono grida che nessuno ascolta.
Essere donna a Gaza significa anche essere madre di molti: dei propri figli, certo, ma anche degli anziani, dei feriti, degli orfani. È un lavoro invisibile, non retribuito, non riconosciuto, eppure decisivo. Se Gaza non è ancora del tutto crollata, è perché le donne tengono insieme ciò che resta della vita quotidiana, come si tengono insieme cocci di una casa bombardata.
Poi c’è la vedovanza. A Gaza la vedovanza non è lutto intimo, è esposizione pubblica. È vulnerabilità. È dover continuare senza protezione, senza reddito, senza sicurezza, mentre il cielo resta ostile. È crescere figli nella paura che il mondo abbia già deciso che non contano.
E infine c’è il corpo ferito: donne operate senza anestesia, cucite senza antidolorifici, curate senza strumenti. Donne che mostrano le cicatrici non per denunciare, ma per chiedere una cosa semplice e disarmante: «Sarò sfigurata?» Come se, anche nella devastazione, restasse il bisogno di sentirsi ancora umane, ancora degne di essere guardate.
La fame, poi, è una violenza che colpisce soprattutto le donne. Sono loro a mettersi in fila per gli aiuti, a rischiare la vita nei punti di distribuzione, a tornare a mani vuote. Sono loro a non avere latte per allattare, a inventare nutrimenti che nutrimento non sono. Scelte che nessuna madre dovrebbe mai essere costretta a fare.
Essere donna a Gaza significa vivere nella contraddizione estrema: generare vita mentre tutto intorno produce morte; continuare ad amare mentre l’amore sembra inutile; tenere in braccio un bambino mentre il mondo discute se quel bambino abbia diritto a vivere.
Eppure, in questo abisso, le donne di Gaza non smettono di essere madri, figlie, sorelle. Non smettono di raccontare. Affidano le loro storie come si affidano reliquie: con la speranza che qualcuno le custodisca, che qualcuno le porti fuori da quell’inferno di polvere e silenzio.
Forse è questo il punto più scandaloso di questa guerra: che l’orrore più grande non è l’esplosione, ma l’abitudine. L’abitudine a vedere donne che soffrono e a voltarsi dall’altra parte. L’abitudine a considerare “inevitabile” ciò che è solo disumano.
Essere donna a Gaza oggi significa sopportare l’insopportabile.
E continuare, ostinatamente, ad amare.