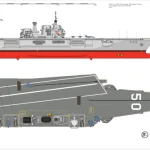Con la morte di Mario Vargas Llosa si spegne una delle voci più libere, lucide e appassionate della letteratura del Novecento. Scrittore peruviano di nascita, cosmopolita per vocazione e spagnolo per scelta, Vargas Llosa ha incarnato una visione della cultura come spazio aperto, come ponte tra le civiltà, come patria senza frontiere. È stato — con Gabriel García Márquez e Julio Cortázar — una delle punte più alte del boom latinoamericano, ma anche qualcosa di più: un uomo del dialogo, dell’impegno civile e della libertà come valore non negoziabile.
A Madrid, in un bar vicino al parco del Retiro, prese la decisione di diventare scrittore. Era il 1958. La Spagna era ancora sotto il giogo del franchismo, ma in quella capitale ancora austera Vargas Llosa trovò una libertà interiore che a Lima gli era stata negata. È lì che nacque la prima bozza de La città e i cani, romanzo che avrebbe scosso le fondamenta della narrativa ispanoamericana.
Quello con la Spagna non fu solo un rapporto sentimentale, ma intellettuale e politico. Nei suoi anni a Barcellona — tra il 1969 e il 1974 — visse e scrisse nella fucina del rinnovamento culturale, accanto a figure come Carlos Barral e Carmen Balcells. Fu testimone e protagonista di una stagione in cui Barcellona diventava crocevia di scrittori, idee e fermenti di libertà. In quella città, durante gli ultimi anni del franchismo, Vargas Llosa comprese il valore della democrazia come conquista e come missione.
Non è un caso che, anni dopo, nel 2017, sia salito su un palco a Barcellona per difendere l’unità della Spagna contro ogni tentazione separatista. Le sue parole in quella occasione non furono dettate da calcoli politici, ma da una fedeltà alla verità storica e culturale che aveva vissuto in prima persona: «Qui gli scrittori spagnoli e latinoamericani si sono ritrovati. Qui si respiravano gli ideali dell’Europa, della civiltà, della democrazia».
Vargas Llosa ha sempre rigettato i totalitarismi, i populismi, le scorciatoie ideologiche. Non fu mai un uomo accomodante: passò dalla sinistra rivoluzionaria al liberalismo classico, dal sostegno alla rivoluzione cubana alla sua critica spietata. La sua coerenza fu proprio nella libertà. La sua posizione, spesso scomoda, fu quella dell’intellettuale che non si inchina al potere, ma lo interroga. È questa libertà che lo ha portato ad accettare la cittadinanza spagnola nel 1993 e ad entrare nella Real Academia Española con il discorso La verdad de las mentiras, dove difendeva la letteratura come scuola di empatia, verità e giustizia.
Per chi scrive in una rivista cattolica, Mario Vargas Llosa resta una figura da leggere e meditare nonostante la sua distanza da un riferimento religioso esplicito. È stato un uomo che ha preso sul serio la coscienza, la verità, la dignità dell’uomo. Ha esplorato il male, la colpa, la redenzione; ha narrato l’ingiustizia, la corruzione del potere, ma anche il riscatto possibile. La sua visione della cultura come battaglia per la libertà interiore non è lontana dal Vangelo, che invita a essere lievito nella massa e a non nascondere la luce sotto il moggio.
Vargas Llosa con i suoi editoriali, specialmente per il quotidiano El Pais, è stato una pietra di paragone per la cultura democratica, per il pensiero critico, per una letteratura che non si chiude in se stessa ma guarda al mondo e alle sue ferite.
L’ultimo saluto che possiamo tributargli è quello della gratitudine. Per averci insegnato che la parola può essere impegno, che la scrittura è un atto di responsabilità e che, anche nella confusione dei tempi, si può restare fedeli alla dignità dell’uomo.
Diceva: “La letteratura non è solo un piacere estetico, ma un modo per esercitare la libertà.”
E questa libertà — oggi più che mai — ha bisogno di testimoni.