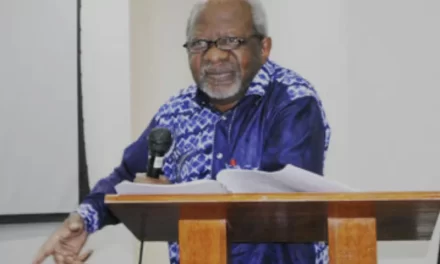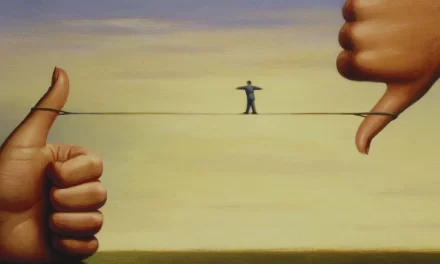“Quando uno combatte solo per se stesso diventa debole. Ma quando ha qualcosa da proteggere… diventa invincibile.”
— Goku
Per milioni di spettatori cresciuti tra gli anni ’80 e 2000, Dragon Ball non è solo un anime: è un mito fondativo. Come le gesta di Ercole o i racconti biblici, le avventure di Goku e dei suoi amici hanno strutturato l’immaginario, il linguaggio e persino l’etica quotidiana di intere generazioni. Ma dietro i combattimenti spettacolari e le trasformazioni sempre più estreme, si cela qualcosa di più profondo: una narrazione antropologica e morale che sfiora, talvolta, il confine con la teologia.
Il combattente e il cuore: etica prima della forza
La struttura narrativa di Dragon Ball è semplice: il protagonista si allena, affronta nemici sempre più forti, cade, si rialza e supera i propri limiti. Ma ciò che colpisce è che il vero potere non deriva mai solo dai muscoli, ma da qualcosa di più: il legame con gli altri, la difesa della vita, l’amore, la misericordia. Goku non combatte per sé, ma per proteggere. E spesso, come nel caso di Vegeta o Majin Bu, lascia una via d’uscita, una possibilità di cambiamento.
In questo, la logica del racconto si allontana dal semplice codice “shonen” per sfiorare la parabola: il nemico può cambiare, l’ultimo può diventare il primo, la morte può essere offerta per amore. Una grammatica narrativa che non dispiacerebbe al Vangelo.
Redenzione, sacrificio, rinascita
Tra gli snodi più potenti della serie c’è la morte e resurrezione di Goku (più volte), spesso in contesti di dono gratuito: si sacrifica per suo figlio, per la Terra, perfino per il nemico. In questo, è quasi una figura cristologica. Certo, non c’è un Dio personale, e la resurrezione viene dalle Sfere del Drago, non dalla grazia divina. Ma il gesto morale del dono di sérimane.
Quando Vegeta, l’orgoglioso principe dei Saiyan, si lascia esplodere per salvare Trunks e la Terra, il suo volto non è più duro, ma sereno: “Finalmente ho capito cosa vuol dire amare qualcuno.” Non serve essere credenti per cogliere il peso salvifico di questa scena.
Mistica da combattimento?
L’apice spirituale arriva con l’Ultra Istinto: uno stato in cui il corpo di Goku si muove da solo, libero da pensiero, ego e reazione. Per raggiungerlo, egli deve liberarsi dall’ira e dall’ansia del vincere. Qui il combattimento diventa esperienza mistica, simile a quella descritta dai Padri del Deserto o dalla spiritualità orientale cristiana: il vuoto che diventa pienezza, l’abbandono che diventa forza. Goku non vince perché vuole vincere, ma perché smette di volerlo.
Certo, non siamo nel Vangelo né nella Filocalia, ma l’intuizione c’è: la vera forza nasce dal silenzio interiore.
Un Vangelo laico per la generazione Z?
Dragon Ball non è una catechesi, né vuole esserlo. La teologia ufficiale della serie è un patchwork di buddhismo, taoismo, politeismo nipponico e fantascienza. Ma i valori morali ed esistenziali che trasmette parlano anche all’uomo religioso:
- che il male può essere vinto, ma anche redento;
- che la giustizia non è vendetta;
- che la forza autentica è servizio;
- che il sacrificio di sé per amore è il più alto gesto umano.
E forse, senza nemmeno volerlo, Goku — che non ha mai letto i Vangeli — si comporta, in fondo, come il buon samaritano: passa, si ferma, si sporca le mani e salva la vita a chi incontra.
Perché rivedere Dragon Ball oggi
In un tempo in cui l’epica è spesso cinica, postmoderna, disillusa, Dragon Ball — con la sua ingenuità e il suo cuore — ricorda ai giovani che la bontà è ancora un valore, che la redenzione è possibile e che l’altro non è un nemico da eliminare, ma una persona da comprendere.
E forse, tra un Kamehameha e una fusione, c’è un messaggio che il cristianesimo stesso può accogliere e reinterpretare: che la vera forza è amare fino in fondo, anche quando tutto sembra perduto.