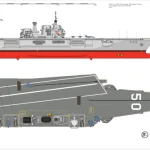L’accordo commerciale siglato tra Unione Europea e Stati Uniti, che prevede l’imposizione di dazi del 15% su numerose merci europee — fino al 50% su acciaio e alluminio — è stato salutato da alcuni come un gesto di stabilità geopolitica. In realtà, si tratta di un nuovo, grave sbilanciamento strutturale che penalizza l’Europa sul piano economico, industriale e morale. Una scelta che contraddice la logica della reciprocità e mina i principi di equità e cooperazione tra i popoli.
Dietro l’apparente “tregua commerciale”, si cela infatti un rapporto asimmetrico e subalterno che si perpetua da decenni: Washington detta le condizioni, Bruxelles le subisce. Il danno, per l’Italia in particolare, è doppio: colpisce settori industriali cruciali e si combina con la pressione del tasso di cambio. A una sovrattassa imposta per decreto si somma infatti una rivalutazione dell’euro che, invece di favorire le esportazioni europee, incentiva quelle americane.
Dazi e dollaro: un doppio cappio
Il vero paradosso di questa situazione sta nel fatto che gli Stati Uniti — mentre impongono dazi sulle merci europee — beneficiano contemporaneamente della svalutazione del dollaro, che rende i loro prodotti più competitivi nel Vecchio Continente. In altre parole, mentre gli europei devono pagare per esportare negli USA, gli americani trovano invece un mercato europeo spalancato e “scontato”.
Per l’Italia, esportatrice netta e con un’economia trainata da manifattura e piccola impresa, la dinamica è devastante. I nostri prodotti, che già scontano costi energetici elevati a causa delle importazioni forzate di gas liquido americano, diventano meno accessibili oltreoceano e più vulnerabili in patria alla concorrenza estera drogata dal cambio.
Il danno non è solo economico: è sistemico. È la testimonianza di un’Europa che rinuncia a parlare con voce propria, e accetta una torsione strategica imposta da logiche elettoralistiche americane, che nulla hanno a che vedere con il bene comune globale.
L’asimmetria morale di un modello tossico
Il cristiano non può limitarsi a denunciare lo squilibrio commerciale. Deve leggere dietro i numeri lo squilibrio morale. I dazi non sono solo tariffe: sono forme moderne di protezionismo aggressivo, che alterano la fiducia tra le nazioni e alimentano la cultura del sospetto e del dominio.
Ciò che viene spacciato come difesa dell’interesse nazionale è, in realtà, la proiezione di un sistema finanziario ipertrofico, incapace di vivere senza deficit strutturale e continuamente in cerca di scorciatoie. Il dollaro debole è funzionale alla riduzione del disavanzo commerciale americano, ma al tempo stesso mina la credibilità globale del biglietto verde, e accresce la volatilità sistemica dei mercati.
Il rischio è che si entri in una spirale autoreferenziale: più l’America si chiude, più deve manipolare gli strumenti monetari e fiscali per restare competitiva. Ma così facendo indebolisce la fiducia internazionale nelle sue stesse istituzioni economiche. Il dollaro, ancora moneta di riserva globale, sta perdendo terreno, e la corsa all’oro e agli asset rifugio ne è una conferma.
L’Europa che cede e quella che può reagire
L’Unione Europea, e con essa l’Italia, si trovano oggi in una posizione delicata. Non è solo una questione di dazi o cambi. È una questione di sovranità economica, di visione comune, e di dignità politica. Continuare a finanziare — direttamente o indirettamente — l’industria americana (dal gas alle armi, passando per i titoli di Stato) senza esigere condizioni e reciprocità, è una forma di auto-sottomissione.
Basti ricordare che, ancora oggi, i Paesi europei detengono oltre 2.400 miliardi di dollari in titoli americani. Un potere potenziale di contrattazione enorme, che però non viene mai esercitato. L’Europa non osa. Si adegua. Preferisce la stabilità apparente all’autonomia vera. Ma in questa scelta c’è il rischio della sterilità strategica.
Il principio di solidarietà e la Dottrina sociale della Chiesa
Come ricorda la Dottrina sociale della Chiesa, l’economia deve essere al servizio dell’uomo e non il contrario. Le relazioni commerciali devono basarsi su giustizia, sussidiarietà e solidarietà tra le nazioni (cfr. Compendio della Dottrina Sociale, n. 363).
Un sistema che arricchisce alcuni imponendo agli altri squilibri strutturali e penalizzazioni competitive è ingiusto. È un modello che produce scarti anche tra le nazioni, non solo tra le persone. È il capitalismo degli “imperi economici”, che sostituisce il diritto con la forza, e la cooperazione con l’imposizione.
In questa logica, l’Europa deve recuperare il coraggio profetico di dire no. Di non accettare dazi e diktat. Di non svendere la propria autonomia industriale e monetaria in nome di una fedeltà transatlantica non più simmetrica. Occorre una nuova virtù politica del rischio, illuminata dalla fede e dalla ragione, capace di anteporre la dignità dei popoli ai vantaggi dei potentati.
Il danno dei dazi USA all’Europa non si misura solo in miliardi, ma in capitale umano, coesione sociale e credibilità politica. A essi si somma il peso occulto di una moneta, il dollaro, che agisce come leva geopolitica travestita da neutralità economica. L’economista cattolico non può restare indifferente.
Il Vangelo ci insegna a costruire ponti, non muri tariffari.
E l’equilibrio tra i popoli si ottiene non con la forza della valuta o dei dazi, ma con l’equità, la giustizia e la fraternità economica.
L’Europa lo ricordi. E non smetta di alzare la testa.