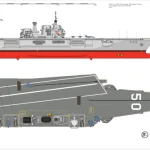C’è un genere di discorsi che non nasce per piacere, ma per scuotere. Quello pronunciato da Mario Draghi a Lovanio, in occasione del conferimento del dottorato honoris causa, appartiene a questa specie rara: non l’ennesima esortazione all’unità europea, bensì una diagnosi tagliente e una proposta che, in Europa, suona ancora quasi indecente per quanto è semplice: se vuoi essere una potenza, devi smettere di essere una confederazione.
Il cuore della tesi è riassunto in una frase che non lascia scampo: un gruppo di Stati che si coordina resta un gruppo di Stati, ognuno con il proprio veto, ognuno con il proprio calcolo, ognuno vulnerabile a essere “preso uno per uno”. E se il mondo torna a funzionare per logiche di potenza, un’Europa che rimane un “grande mercato” rischia di diventare, simultaneamente, subordinata, divisa e deindustrializzata.
L’ordine morto e il ritorno del costo della dipendenza
Draghi parte da una constatazione che vale come epitaffio del dopoguerra: l’architettura europea è cresciuta dentro un ordine internazionale basato sul diritto, su istituzioni credibili e soprattutto su una dottrina di sicurezza garantita dagli Stati Uniti. Non era un’illusione: quel sistema ha prodotto pace e prosperità. Ma ha anche creato una condizione psichica – oltre che strategica – che oggi non regge più: l’idea che l’interdipendenza sia sempre un vincolo reciproco, e mai un’arma.
Ecco il passaggio decisivo: quando la globalizzazione si intreccia con rivalità geopolitiche, l’interdipendenza smette di essere un “morbido” incentivo alla cooperazione e diventa leva di controllo. Pechino domina nodi critici di filiera; Washington, nella postura evocata da Draghi, misura l’alleanza in termini di costi e non di benefici e non nasconde di preferire un’Europa frammentata. In mezzo, l’Unione rischia di pagare due volte: con la vulnerabilità e con la tentazione di rinunciare ai propri valori per conservare qualche protezione.
La grande frattura europea: commercio federale, difesa confederale
Il ragionamento ha un’eleganza quasi crudele. Dove l’Europa si è federata – mercato unico, concorrenza, politica commerciale, moneta – parla con una sola voce e viene trattata come potenza. Dove non lo ha fatto – difesa, politica estera, politica industriale, fisco – viene trattata come somma di medie potenze, ciascuna negoziabile e ricattabile.
In altre parole: la potenza commerciale europea non compensa le fragilità strategiche; anzi, in un mondo duro, può diventare il punto d’appoggio con cui altri esercitano pressione sulle dipendenze europee (energia, tecnologia, sicurezza). È la fine dell’ingenuità: commercio e sicurezza non coincidono più.
“L’unità non precede l’azione”: la teologia laica della decisione
Il passaggio più interessante – e forse più impopolare – è quello metodologico. Draghi rovescia la vecchia liturgia brussellese: non dobbiamo aspettare di essere più uniti per agire; è agendo insieme che si diventa uniti. L’unità non è un presupposto morale, è un prodotto politico: si costruisce con decisioni comuni, con costi condivisi, con responsabilità che generano solidarietà. È un’idea profondamente “schumaniana”: l’Europa nasce quando smette di fare dichiarazioni e comincia a vincolarsi.
Da qui la formula che Draghi chiama “federalismo pragmatico”: non l’utopia di una federazione totale e immediata, ma una dinamica a cerchi concentrici, una “coalizione di volenterosi” nei settori dove è possibile avanzare subito (difesa, tecnologia, energia, politica estera), mantenendo aperta la porta agli altri, ma non a chi paralizza l’obiettivo comune.
Il caso Groenlandia come parabola: la minaccia che costringe a diventare adulti
Draghi evoca la Groenlandia non per gusto dell’episodio, ma come parabola della maturità: una minaccia diretta costringe l’Europa a fare ciò che di solito evita – mappare interessi, strumenti, escalation, conseguenze – e, nel farlo, scopre una solidarietà che nessun comunicato di vertice riesce a produrre. È la politica nella sua verità: la paura può avviare l’unità, ma solo l’azione può trasformarla in istituzione.
Il limite e la provocazione: una federazione senza “subordinazione”
Draghi insiste su un punto che vale come antidoto a due caricature: l’integrazione europea non deve imitare né la verticalità cinese né l’asimmetria americana. Non “partnership per dominare”, non crescita scaricando costi sugli altri: semmai un modello più difficile e più esigente, perché fondato su volontà comune e condivisione dei benefici. Ma proprio per questo, avverte Draghi, è più arduo: richiede istituzioni con potere decisionale reale e la disponibilità degli Stati a rinunciare al conforto del veto.
Il sottotesto: l’Europa come destino, non come comfort zone
Il discorso di Lovanio, letto fino in fondo, non è solo geopolitica: è sociologia dell’Europa. Draghi descrive una civiltà che, per settantacinque anni, ha potuto permettersi di essere un grande mercato con una coscienza morale; ora deve decidere se vuole essere anche un soggetto storico capace di difendere interessi e valori nello stesso gesto. Perché, come nota con severità, un continente incapace di difendere i propri interessi non conserverà a lungo i propri valori.
È qui la provocazione più scomoda: il federalismo non è romanticismo europeista, è una risposta al ritorno del mondo come conflitto di potenze. E il prezzo dell’indecisione non sarà una “minore influenza”; sarà una lenta trasformazione dell’Europa in spazio conteso, trattato e ridisegnato da altri.
Se vuoi, posso trasformare questo elzeviro in una versione “terza pagina” ancora più letteraria (con un parallelo storico: dalla Confederazione americana pre-1787 al Federalist moment) oppure in un taglio più da quotidiano economico, con implicazioni su difesa comune, debito europeo e politica industriale.