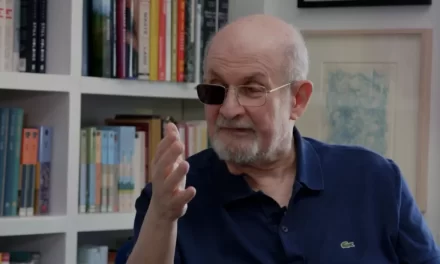Il 23 maggio 1992, l’autostrada tra l’aeroporto di Punta Raisi e Palermo fu squarciata da una bomba. A morire furono Giovanni Falcone, Francesca Morvillo e gli agenti della scorta. A sopravvivere, tra memoria e ferite aperte, fu la domanda: è lo Stato a celebrare Falcone, o a doversene ancora vergognare?
Il tempo non ha cancellato l’eco della deflagrazione di Capaci. Trentadue anni dopo, quel cratere sull’autostrada A29 continua a essere una ferita aperta nella coscienza della Repubblica. Giovanni Falcone, Francesca Morvillo, Vito Schifani, Rocco Dicillo e Antonio Montinaro non sono morti per un errore, ma per un messaggio. L’ordine di ucciderli fu un atto deliberato di guerra contro lo Stato, ma anche — come oggi sappiamo — la punta dell’iceberg di un sistema più vasto, fatto di complicità, silenzi e strategie indicibili.
Le sentenze definitive hanno accertato la responsabilità dei vertici di Cosa Nostra: Totò Riina in primis, insieme a Brusca, Graviano, Bagarella e altri nomi che sono entrati nell’oscura liturgia dell’orrore mafioso. Ma negli anni si sono fatti sempre più insistenti, anche in sede giudiziaria, i sospetti su una regia più ampia. La cosiddetta “trattativa Stato-Mafia” ha lasciato un segno indelebile: nella possibilità che pezzi delle istituzioni abbiano preferito negoziare con i carnefici anziché proteggere le vittime.
Celebrarne oggi la memoria non è un gesto retorico, ma un atto politico. Perché Falcone non fu un eroe solitario. Fu un magistrato rigoroso, un uomo dello Stato, con una visione lucida del crimine organizzato come struttura di potere, non solo di violenza. Aveva intuito che per colpire la mafia serviva un attacco al suo cuore economico, ai suoi legami trasversali, al consenso che generava attraverso la paura e l’omertà. Ma sapeva anche di essere sempre più isolato. Lo disse chiaramente: «Sono un sopravvissuto». E in un sistema che si è spesso rivelato pavido, ha pagato con la vita il coraggio di non cedere.
Francesca Morvillo, sua compagna e magistrata, fu colpita due volte: come donna e come simbolo di una giustizia che non si piega. La loro storia d’amore, fusa con la missione condivisa, è parte integrante di quella memoria da coltivare.
E cosa dire dei tre agenti della scorta? Non erano «collaterali», come qualcuno si ostinò a pensare. Erano uomini dello Stato. Lo Stato li aveva armati, ma non sempre protetti. Portavano la responsabilità di difendere un uomo già condannato dalla mafia, con le stesse probabilità di morire.
Gli uomini passano, le idee restano e continuano
Giovanni Falcone
a camminare sulle gambe di altri uomini
Perché ricordare oggi?
Perché la Sicilia non è più la stessa — eppure ancora troppo simile a sé stessa. Se da un lato l’antimafia sociale è diventata una linfa civica per tanti giovani e realtà associative, dall’altro esiste una “mafia in doppio petto” che ha imparato a convivere con il potere economico e politico senza bisogno di stragi. L’omertà ha cambiato forma, la paura pure. Ma l’ingiustizia resta un sottofondo quotidiano: nei quartieri abbandonati, nelle scuole che chiudono, nei diritti negati.
Celebrando Falcone, celebriamo l’idea che la giustizia non è una parola astratta, ma una pratica quotidiana, che richiede coerenza e solitudine. La sua eredità, oggi, dovrebbe fare i conti non solo con le commemorazioni ufficiali, ma con il coraggio di chi nei territori combatte nuove forme di dominio: mafie liquide, poteri opachi, disuguaglianze strutturali.
Per questo il 23 maggio non è solo una data. È un test. Ogni anno che passa ci chiede: siete ancora degni di quei morti?
Falcone non credeva negli eroi, ma negli uomini giusti. Tocca a noi non tradirli.