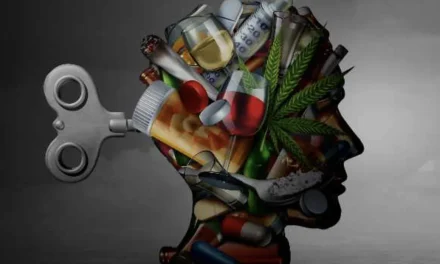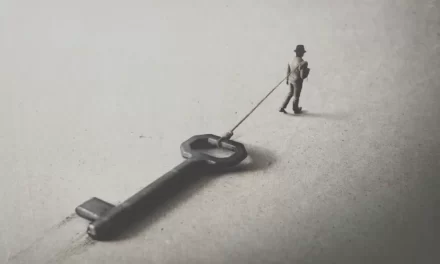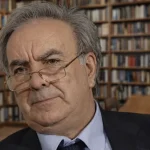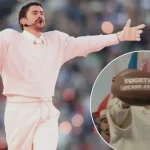Dieci anni dopo il Bataclan, la Francia continua a parlare di quella notte come se fosse ieri.
Non solo per l’orrore — quello resta inciso nella memoria collettiva — ma perché il 13 novembre 2015 fu molto più di un attentato: fu uno specchio.
E ciò che la République vide riflesso non le piacque affatto.
All’epoca si cercò di liquidare tutto con la formula “nemici esterni”. L’ISIS, la rete internazionale, la barbarie importata. Ma, presto, la Francia dovette ammettere la parte più dolorosa: molti degli attentatori erano figli suoi, cresciuti nelle sue periferie, nati con passaporto francese e identità spezzata.
Non estranei: francesi senza Francia.
È qui che il Bataclan assume un significato ulteriore. Non fu solo terrorismo: fu un grido contro il vuoto identitario di una nazione che da anni non sa più spiegare cosa significhi essere “francesi”.
La scuola repubblicana, un tempo tempio della laïcité, non riesce più a creare appartenenza.
Le banlieue, invece, creano un altro tipo di appartenenza, fragile e rabbiosa, dove l’islam radicale diventa la scorciatoia verso un’identità che protegge, unisce, dà una missione.
Le intelligence francesi conoscevano molti nomi, molte facce. Eppure gli uomini del Bataclan passarono.
Non serve immaginare complotti: basta pensare a un Paese che per anni ha preferito rimuovere, ritardare, delegare.
Un Paese che ha gestito la crisi delle banlieue come l’Italia degli anni Ottanta gestiva le sue crisi di governo: cambiando premier ogni pochi mesi, senza cambiare davvero nulla.
E così, quando la Francia fu colpita, scoprì una verità che oggi, dieci anni dopo, è ancora difficile pronunciare: il terrorismo jihadista è stato anche un figlio indesiderato della crisi identitaria francese.
Non nasce nel deserto siriano: nasce nel deserto sociale della periferia europea.
C’è poi un nodo ancora più scomodo: la République ama raccontarsi come patria dei diritti e della neutralità, ma negli ultimi decenni ha lasciato crescere un’intera generazione che non si sentiva né vista né riconosciuta.
E quando uno Stato non dice più chi è, non può pretendere che i suoi figli sappiano chi essere.
Il Bataclan, allora, resta questo: un dolore immenso, un trauma nazionale, e un capitolo che obbliga la Francia a ripensarsi.
Non bastano norme sulla sicurezza. Non basta invocare la laicità. Non basta ammonire l’islam radicale.
Serve qualcosa di infinitamente più semplice e più difficile: ritrovare un “noi” convincente, capace di includere senza annacquare, di integrare senza dissolvere, di educare senza moralismi.
Dieci anni dopo il Bataclan, la domanda per la Francia non è “come prevenire il prossimo attentato?”.
È più profonda, più inquieta, più decisiva: Chi vogliamo essere?
Perché una nazione che non sa rispondere, alla lunga, genera i suoi stessi fantasmi.