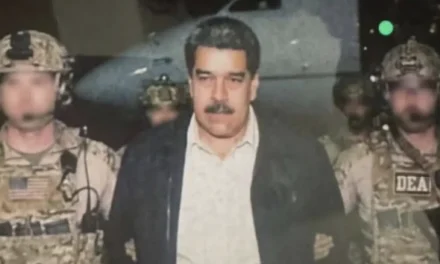L’offensiva “Carri di Gedeone” svela il vero obiettivo del governo Netanyahu: non salvare gli ostaggi, ma svuotare la Striscia. E cancellare un popolo.
Quando si usano parole come “trasferimento per sicurezza” e “complessi umanitari sorvegliati”, mentre le truppe occupano e le bombe cadono, occorre porsi una domanda semplice ma decisiva: stiamo assistendo a un’operazione militare o a un esperimento di ingegneria demografica? Il nuovo piano del governo Netanyahu per Gaza, denominato Operazione Carri di Gedeone, ha poco a che fare con la protezione della popolazione e molto con il consolidamento di una visione politica: quella di una Gaza senza più palestinesi.
Non si tratta di congetture. È stato lo stesso primo ministro israeliano ad affermare che l’obiettivo è il “trasferimento della popolazione”, una dichiarazione che, in diritto internazionale, ha un nome preciso: deportazione forzata. Ed è stato il suo ministro delle Finanze, Bezalel Smotrich, ad ammettere senza vergogna che “la parola occupazione non deve farci paura”.
La nuova fase del conflitto, approvata all’unanimità dal gabinetto di sicurezza israeliano, prevede un’escalation militare, l’ingresso fisso di truppe nella Striscia e un controllo diretto dei territori. È la trasformazione di Gaza da territorio assediato a territorio occupato. Il linguaggio usato – “zone umanitarie protette”, “sfollamento per la sicurezza” – è la foglia di fico di un progetto più antico: ridisegnare la geografia demografica palestinese per rendere impossibile ogni forma di ritorno.
Intanto, decine di migliaia di riservisti vengono richiamati. Il costo previsto? Oltre 3,8 miliardi di euro. Un prezzo che non sarà solo economico, ma anche etico e umano. L’esercito israeliano sta infatti creando una nuova rete di centri di distribuzione di aiuti nel sud della Striscia, gestiti da appaltatori privati e sorvegliati dai militari. L’OCHA (Ufficio ONU per gli affari umanitari) ha già denunciato che questo modello “viola i principi fondamentali del diritto umanitario”: spinge i civili in zone militarizzate, li espone a nuovi pericoli e nega ogni reale autonomia.
Ciò che si profila è un modello tragicamente noto: quello della guerra in Iraq, con zone recintate, militarizzate, affidate a contractor, dove l’aiuto umanitario diventa strumento di controllo e pressione. Il tutto, con la retorica dell’umanitarismo, mentre oltre il 70% di Gaza è già evacuato o sotto diretto controllo israeliano.
Le dichiarazioni ufficiali parlano di combattere Hamas e liberare gli ostaggi. Ma in Israele cresce l’opposizione: manifestazioni a Gerusalemme, famiglie degli ostaggi che denunciano il cinismo del governo, analisti che accusano Netanyahu di prolungare la guerra per sopravvivere politicamente e sfuggire al processo giudiziario che lo attende. A pagarne il prezzo, come sempre, saranno i più deboli: civili palestinesi e soldati israeliani mandati a combattere una guerra senza fine.
Il rischio che si corre è doppio. Da un lato, la distruzione fisica e sociale di Gaza, ormai prossima al collasso. Dall’altro, l’erosione morale dello Stato israeliano, che tradisce i principi fondatori in nome di una logica di potenza che somiglia sempre più a quella dei regimi che lo circondano.
E in mezzo a tutto questo, la comunità internazionale – Europa in testa – balbetta, divisa tra prudenza diplomatica e paralisi morale. Ma oggi non bastano più appelli generici. Serve una presa di posizione netta contro qualunque progetto di “svuotamento” etnico, anche se firmato da un alleato storico. Tacere significa avallare.
Se davvero il presidente Trump visiterà la regione nei prossimi giorni, come previsto, e se davvero intende promuovere un piano di “ricostruzione” nella Gaza svuotata, non potrà sottrarsi alla verità dei fatti: un piano di ricostruzione che parte dalla distruzione e dalla deportazione non è altro che una pulizia etnica mascherata.
Chi crede nella pace, nella giustizia e nella dignità di ogni persona – sia essa israeliana o palestinese – non può non gridare con forza che Gaza non è una terra da conquistare. È una ferita aperta dell’umanità. Ed è proprio da lì, dal riconoscimento della sofferenza e della responsabilità, che può rinascere la possibilità di un dialogo.