S. Francesco ebbe il dono dei primi compagni che oggi, sepolti accanto alla sua tomba, aspettano con lui la resurrezione dai morti dopo aver costruito l’Ordine e custodito il carisma in comunione con la Chiesa.
C’è un equivoco che ritorna, come una tentazione ricorrente, nella storia delle nuove congregazioni: l’idea che il carisma coincida con il fondatore, e che dunque la sorte dell’opera sia legata in modo quasi sacrale alla biografia di chi l’ha avviata. È un equivoco comprensibile — perché i carismi nascono spesso nella forma concreta di una voce, di un’intuizione, di una personalità che attira — ma è un equivoco teologicamente fragile. E soprattutto diventa devastante quando il fondatore “prende degli scivoloni”: morali, spirituali, di governo, di obbedienza ecclesiale. In quel momento, la domanda non è più solo psicologica o giuridica. È ecclesiologica: chi custodisce il carisma quando l’iniziatore lo compromette?
L’esperienza della Chiesa suggerisce una risposta controintuitiva e insieme antica: spesso non lo custodisce il singolo, ma la comunità fondazionale primitiva. Quella prima fraternità — fatta di volti, di relazioni, di consuetudini, di sacrifici — è più che un contorno biografico. È, in un certo senso, il primo “luogo teologico” del carisma: la prima verifica storica del fatto che quell’intuizione non era soltanto un’idea privata, ma una grazia capace di generare vita comune, missione, fecondità ecclesiale.
Qui la Scrittura offre una chiave decisiva. Il carisma, nel Nuovo Testamento, non è mai un possesso individuale: è un dono “per l’utilità comune” (cf. 1Cor 12). E la Chiesa primitiva vive proprio di questo: nessuno è padrone dell’evento; neppure gli Apostoli lo sono in senso proprietario. La comunità discerne, corregge, invia, ratifica. Persino Paolo — carismatico per eccellenza — va a Gerusalemme “per non correre invano” (cf. Gal 2,2). Non è una formalità: è il riconoscimento che l’esperienza dello Spirito chiede un corpo, una comunione che la misura e la purifica.
Quando un fondatore sbaglia, questo principio torna a brillare come una lampada accesa nel buio: il carisma non muore necessariamente con la caduta di chi lo ha innescato, perché non nasce dalla sua virtù, ma dalla libertà di Dio. Tuttavia, proprio perché viene da Dio e non dal fondatore, esso deve essere difeso dal rischio più sottile: essere trasformato in una “religione del fondatore”. In altre parole, l’opera può sopravvivere solo se si separa — con dolore e lucidità — il dono dallo strumento, la grazia dalla mitologia.
È qui che la comunità primitiva fondazionale assume un ruolo che potremmo chiamare ministero di custodia. Essa conserva ciò che è originario non come feticcio, ma come orientamento. Sa distinguere — più di chiunque altro — tra l’ispirazione iniziale e le successive incrostazioni: le rigidità, le “regole parallele”, i linguaggi assolutizzanti, le pretese di eccezionalità, le derive settarie dell’obbedienza, le opacità economiche, le ambiguità nei rapporti di coscienza. La comunità delle origini ha visto con i propri occhi quando l’ispirazione era puro Vangelo e quando, invece, si è cominciato a confondere il servizio con il controllo.
Teologicamente, questa funzione è preziosa perché impedisce due opposti errori.
Il primo errore è il cinismo: “Se il fondatore cade, allora tutto era falso”. Non è vero. Nella storia della salvezza, Dio scrive diritto su righe storte; e la santità di un’opera non coincide in modo meccanico con la santità di un singolo. Altrimenti la Chiesa stessa, fatta di peccatori, sarebbe impossibile. La comunità fondazionale può testimoniare che, nonostante le ombre, in quell’esperienza c’era anche luce reale: vocazioni autentiche, frutti di conversione, servizio ai poveri, fedeltà alla preghiera, slancio missionario. Non tutto va buttato.
Il secondo errore è l’idolatria istituzionale: “Non importa ciò che è successo, l’opera va difesa comunque”. Anche questo è falso, e più pericoloso, perché trasforma la grazia in ideologia. Qui la comunità primitiva è spesso la prima a dire: “No, non possiamo salvare il carisma negando la verità”. Perché la verità non è un accessorio morale; è parte della forma evangelica. Un carisma che si difende con la menzogna o con il silenzio non è più carisma: è un sistema.
Da qui nasce un criterio decisivo: nelle nuove congregazioni, la comunità fondazionale primitiva non è solo “memoria”; è coscienza critica. È l’organo che può aiutare la Chiesa a compiere quel discernimento che il Magistero richiede quando parla di “verifica dei carismi” e di “purificazione” delle forme di vita consacrata. Il suo compito, in concreto, è triplice.
- Custodire la sorgente: non il culto della personalità, ma la semplicità iniziale, la forma evangelica nuda, ciò che era davvero dono e non costruzione.
- Denunciare le deformazioni: perché le derive non arrivano all’improvviso; crescono in silenzio, e spesso sono giustificate “in nome del carisma”.
- Consegnare il carisma alla Chiesa: cioè sottrarlo alla proprietà privata e ricollocarlo nella comunione ecclesiale, sotto il Magistero e le strutture di garanzia (statuti, governo, trasparenza, vigilanza).
In questo senso, paradossalmente, quando un fondatore “scivola”, la comunità primitiva può diventare la vera fondatrice ecclesiale dell’opera: non perché inventi un altro carisma, ma perché lo libera dal suo involucro patologico. È un lavoro pasquale: perdita, purificazione, ricostruzione. E in questa Pasqua l’opera impara finalmente ciò che doveva sapere dall’inizio: che non esiste carisma senza croce, e che la croce, nella vita ecclesiale, spesso prende la forma umile e concreta della verità detta, della responsabilità assunta, della giustizia resa, della comunione ricostruita.
C’è anche un’ultima lezione, più profonda. La comunità fondazionale primitiva ricorda alla Chiesa che il carisma non è una “creazione” ma una “ricezione”. Nessuno può vantarsene. Nessuno può brandirlo. E proprio per questo, quando il fondatore tradisce, la comunità può dire — con fermezza e senza odio — ciò che è teologicamente inevitabile: l’iniziatore storico resta un dato di fatto; ma il “fondatore carismatico”, in senso ecclesiale, è colui la cui vita conferma il dono con la fedeltà, l’obbedienza e la trasparenza. Se queste mancano, la Chiesa non umilia: semplicemente non canonizza.
In tempi in cui la vita consacrata è chiamata a uscire dalle retrotopie e dalle narrazioni autocelebrative, questa prospettiva è ossigeno. Perché salva insieme tre beni: la verità delle vittime, la purificazione delle istituzioni e la continuità dei doni di Dio. E ci consegna un criterio sobrio ma luminoso: quando un fondatore cade, la domanda non è “chi difenderà l’immagine?”, ma “chi custodirà il Vangelo?”. Spesso la risposta è proprio lì, nelle mani di quella prima comunità che ha amato senza mitizzare, che ha creduto senza idolatrare, che ha servito senza possedere.













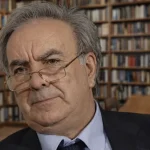





Testo chiaro e coraggioso. Dall’abbigliamento dell’avatar non so se l’autore è un frate o un inviato di guerra o forse entrambe le cose. L’analisi comunque mi è piaciuta sia sul piano teologico che sociologico e storico. Abbiamo bisogno di fare chiarezza nella Chiesa perché un tempo essere fondatori o fondatrici significava canonizzazione automatica. In tempi recenti ci sono stati tanti scivoloni che continuano a dare scandalo al popolo di Dio. Il vero problema, però, sono i membri e i sodali di un istituto religioso di un fondatore decaduto. La storia della salvezza nella genealogia umana di Gesù ci insegna che anche da peccatori può nascere il Messia. È quindi fondamentale separare il carisma dal fondatore individuando l’eventuale prossimità al pensiero di un santo già canonizzato ma valorizzando anche il ruolo non indifferente della comunità iniziale, senza la quale il fondatore poco o niente avrebbe fatto. Queso va detto per onestà intellettuale senza romanticismi.
Condivido il commento di don Fiorenzo, oltre all’apprezzamento dell’articolo. C’è però una variabile che è la possibile complicità – fino alla deriva settaria – della comunità primitiva iniziale. L’esperienza dei Legionari di Cristo è un esempio paradigmatico di come il fondatore fosse coperto dai senatori dell’istituto. La Provvidenza poi ha voluto che anche i senatori uscissero volontariamente dall’Istituto o fossero allontanati coattivamente.