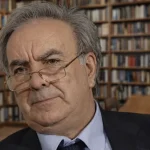Davanti alle stelle d’oro dell’Unione, i presidenti delle Conferenze episcopali di Francia, Germania, Italia e Polonia si presentano come “pellegrini di speranza”: non un’Europa ridotta a mercato, ma una casa comune capace di anima, dialogo e bene comune in un mondo lacerato da guerre e polarizzazioni.
L’Europa, oggi, somiglia a quel grande atrio di stazione dove tutti passano e pochi sostano: si corre, si discute, ci si urta; e intanto si perde la domanda decisiva: perché siamo qui, insieme, su questo stesso binario di storia? L’appello “Cristiani per l’Europa. La forza della speranza”, firmato dai presidenti delle Conferenze episcopali di Francia, Germania, Italia e Polonia, arriva come un colpo di campana dentro il frastuono: «Il mondo ha bisogno dell’Europa». Non è uno slogan identitario; è una diagnosi sul presente e un compito per il futuro.
L’Europa, oggi, somiglia a quel grande atrio di stazione dove tutti passano e pochi sostano: si corre, si discute, ci si urta; e intanto si perde la domanda decisiva: perché siamo qui, insieme, su questo stesso binario di storia? L’appello “Cristiani per l’Europa. La forza della speranza”, firmato dai presidenti delle Conferenze episcopali di Francia, Germania, Italia e Polonia, arriva come un colpo di campana dentro il frastuono: «Il mondo ha bisogno dell’Europa». Non è uno slogan identitario; è una diagnosi sul presente e un compito per il futuro.
La prima cosa che colpisce è il tono: non la nostalgia, ma l’urgenza. «Viviamo in un mondo lacerato e polarizzato da guerre e violenza… l’ordine internazionale è minacciato», scrivono i firmatari, raccogliendo l’invito di Papa Leone XIV, a conclusione del Giubileo, a continuare a essere “pellegrini di speranza”. È un passaggio decisivo: la speranza, qui, non è sentimento devoto; è categoria pubblica. È la forza che impedisce alla paura di diventare sistema e al cinismo di diventare cultura.
Il punto, però, è quale Europa serva al mondo. L’appello è netto: l’Europa non può essere ridotta a mercato e tecnocrazia senza tradire la propria origine. Per questo ritorna ai padri fondatori non come santini d’archivio, ma come grammatica minima di una civiltà che ha imparato—nel modo più tragico—che il nazionalismo, quando si fa assoluto, diventa religione rovesciata, idolatria della nazione. Da qui la citazione—fortissima—attribuita a De Gasperi: «Il nazionalismo esacerbato è una forma di idolatria»; e l’altra, altrettanto tagliente: «L’Europa unita non è nata contro le patrie, ma contro i nazionalismi che le hanno distrutte».
In questo senso, il testo ha un coraggio controcorrente: osa dire che, in un’epoca di frantumazione, la risposta non è la somma dei ripiegamenti. Perché l’isolazionismo promette protezione, ma produce solitudine geopolitica; promette identità, ma genera rivalità; promette sicurezza, ma lascia in eredità il sospetto. L’appello, invece, chiede sovranazionalità come cura dei conflitti, dialogo come metodo, alleanze come solidarietà reale tra i popoli.
E qui entra la parola più “politica” e più cristiana insieme: carità. Non in versione sentimentalista, ma come forma adulta della responsabilità. Robert Schuman—ricordato nel documento—lo diceva con una frase che resta modernissima: «Vissuta come impegno disinteressato al servizio della città, al servizio dell’uomo, la politica può diventare un impegno d’amore verso il proprio simile». È la definizione più semplice e più esigente di “vocazione” civile: la politica non come carriera, ma come custodia dell’umano.
C’è, però, un passaggio ancora più delicato: l’appello non nega il pluralismo europeo; lo abita. Dice, in sostanza: siamo meno numerosi, ma non per questo meno responsabili. In un continente plurale per lingue, culture e tradizioni spirituali, i cristiani sono chiamati a condividere con tutti una speranza di fraternità universale. Non è una pretesa di egemonia; è un’offerta di servizio. Qui sta la differenza tra “radici” usate come clava e “radici” vissute come linfa: le prime feriscono, le seconde nutrono.
Un elzeviro, per definizione, deve anche saper dire l’implicito: questo testo non nasce nel vuoto. Quando scrive che “un quadro internazionale sta morendo e uno nuovo deve ancora nascere”, fotografa una fase di transizione in cui l’Europa rischia due tentazioni opposte: l’irrilevanza (ritirarsi, delegare, lamentarsi) e l’irrigidimento (chiudersi, alzare muri, trasformare la paura in programma). L’appello propone una terza via: riscoprire l’anima per servire il bene comune, cioè tornare a essere ciò che l’Europa ha saputo essere nei suoi giorni migliori: un laboratorio di riconciliazione, una “solidarietà di fatto” costruita per passi concreti.
Resta la domanda finale, quella che riguarda noi—credenti e cittadini—molto più delle istituzioni: dove ricominciamo?Forse da un piccolo esame di coscienza collettivo: quanta parte della nostra conversazione pubblica è diventata sordità? quanta parte della nostra fede si è fatta risentimento? quanta parte della nostra identità è una coperta con cui escludere invece che una casa da aprire?
Se il mondo ha bisogno dell’Europa, l’Europa ha bisogno, anzitutto, di ritrovare la propria misura: non la grandezza imperiale, ma la grandezza umana. E se i cristiani vogliono essere “forza della speranza”, devono accettare la fatica di una speranza che non grida, ma costruisce; non si compiace di avere ragione, ma cerca il bene; non si rifugia nei simboli, ma pratica la fraternità—anche quando costa.