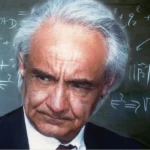Ancora un caso in Veneto di un prete che lascia la tonaca. Non un fallimento, una domanda
C’è un dettaglio che sfugge facilmente, quando le cronache raccontano un parroco che chiede la dispensa, una comunità che cambia guida, un’altra che si “accorpa” e un’altra ancora che resta senza Messa feriale: non siamo solo davanti a un’emergenza organizzativa. Siamo davanti a una domanda spirituale e culturale che si impone alla Chiesa italiana nel suo insieme — Nord e Sud, città e paesi, diocesi “ricche” e periferie — e che non può essere liquidata né con il moralismo né con l’ironia di paese.
Il fenomeno dei preti che lasciano il ministero per una relazione affettiva, o semplicemente perché non reggono più una solitudine diventata peso, si intreccia con almeno tre fratture: il calo delle vocazioni, l’assottigliarsi delle comunità praticanti, la trasformazione del sacerdote in “trottola” tra parrocchie — e talvolta in burocrate di sacramenti, oltre che in gestore di immobili e bollette. Sullo sfondo c’è l’eredità di scandali che hanno ferito la fiducia, ma anche una domanda più profonda: che cosa rende oggi desiderabile la vita cristiana, e in che modo il ministero ordinato può tornare a essere segno di pienezza e non di esaurimento?
Qui serve un primo distinguo, elementare ma decisivo. Il prete diocesano e il religioso vivono due grammatiche diverse. Il primo è incardinato in una Chiesa particolare, spesso solo nella responsabilità quotidiana, dentro un tessuto sociale che cambia più in fretta delle strutture pastorali. Il secondo appartiene a una famiglia carismatica: una fraternità, una regola, una missione condivisa che, quando è vissuta bene, offre un contesto umano e spirituale di sostegno (anche se non immunizza dalle crisi). Confondere i piani produce ingiustizie: si giudica un’esperienza con categorie che non le appartengono.
Detto questo, un secondo punto va pronunciato con rispetto e senza ammiccamenti: l’amore umano non è un nemico della fede. È un linguaggio della creatura, una via in cui molti scoprono la responsabilità, la cura, la fedeltà, la pazienza. Demonizzarlo significa diventare acidi; e l’acidità — anche quando si traveste da “rigore” — non genera vita, genera difesa. Non è un caso che, quando la verità viene separata dall’amore, sterilizza: si fa sentenza, non Vangelo; si fa controllo, non paternità. E alla lunga, paradossalmente, indebolisce proprio ciò che vorrebbe proteggere: la credibilità del ministero.
Ma attenzione: evitare l’acidità non significa banalizzare. La questione non è “romanticizzare” la crisi, né trasformare ogni scelta in diritto automatico. La questione è più esigente: discernere. Discernere significa riconoscere che ci sono situazioni diverse: chi vive una fragilità che avrebbe chiesto accompagnamento prima; chi ha attraversato ferite antiche; chi è stato formato a un’idea idealizzata del sacerdozio senza un’adeguata educazione affettiva; chi è stato schiacciato da una pastorale senza respiro; chi ha confuso il bisogno di intimità con la ricerca di senso. Mettere tutto nello stesso sacco — “traditori”, “inermi”, “scandalo” — è un modo pigro di non capire.
E tuttavia la Chiesa non può neppure ignorare un dato: il modello del “prete-solitario-tuttofare” è spesso diventato strutturalmente insostenibile. Quando una diocesi copre decine e decine di parrocchie con un numero ridotto di presbiteri anziani, il problema non è solo numerico: è ecclesiologico. Si rischia di costruire comunità che “girano attorno al prete”, mentre il Vangelo e la migliore tradizione pastorale chiedono l’opposto: comunità adulte, corresponsabili, capaci di pregare, servire, educare, evangelizzare. In questo senso, il maggiore coinvolgimento dei laici non è una toppa; è un ritorno alla realtà della Chiesa come popolo in cammino, dove il ministero ordinato non viene sostituito, ma liberato dalla caricatura del monopolio.
Arriviamo così al nodo che torna periodicamente con una forza quasi emotiva: il celibato. È inutile fingere che non ci sia un dibattito e che non sia stringente. Ma è altrettanto inutile presentarlo come la chiave magica di tutto. La crisi vocazionale ha cause complesse: demografia, cultura, sfiducia, mobilità sociale, fragilità relazionali, trasformazione del ruolo pubblico della Chiesa. Chi riduce tutto a una sola leva — “basterebbe cambiare questo e…” — fa torto alla realtà. E fa torto anche a molti sacerdoti che vivono con gioia la scelta celibataria come forma di amore oblativo e di libertà per il Regno.
La domanda vera, allora, per una riflessione “da terza pagina” non è solo normativa. È spirituale e pastorale: come testimoniare una vita piena? Come evitare che il ministero appaia come una rinuncia senza promessa, un servizio senza fraternità, una missione senza casa? Come formare presbiteri che non siano funzionari del sacro né solisti eroici, ma uomini di comunione, capaci di amicizia, di riposo, di lavoro condiviso? E come aiutare chi non regge più a scegliere con verità, senza doppiezza e senza spettacolarizzazione?
C’è un’ultima domanda, forse la più evangelica: che cosa ci chiede tutto questo, come Chiesa? Non di “salvare l’istituzione” con strategie di marketing spirituale, ma di ritrovare un linguaggio e una prassi in cui la paternità sacerdotale non sia un titolo, bensì una forma di amore. La verità resta necessaria; ma senza amore diventa sterile. E una Chiesa sterile — anche se impeccabile nei protocolli — non genera vocazioni, non accende i giovani, non consola gli stanchi, non riapre i cuori.
Se vogliamo un criterio semplice per non perderci: non si tratta di giudicare la vita privata — quello lo fa Dio — ma di custodire la credibilità di una missione. Credibilità non è severità, è trasparenza; non è durezza, è carità nella verità; non è nostalgia, è coraggio di forme nuove. E il coraggio, oggi, chiede una cosa concreta: comunità che tornino a essere comunità, non uffici sacramentali; preti che non siano soli; laici non spettatori; e una Chiesa capace di parlare dell’amore umano senza paura, perché sa che l’Amore più grande non lo teme, lo illumina.