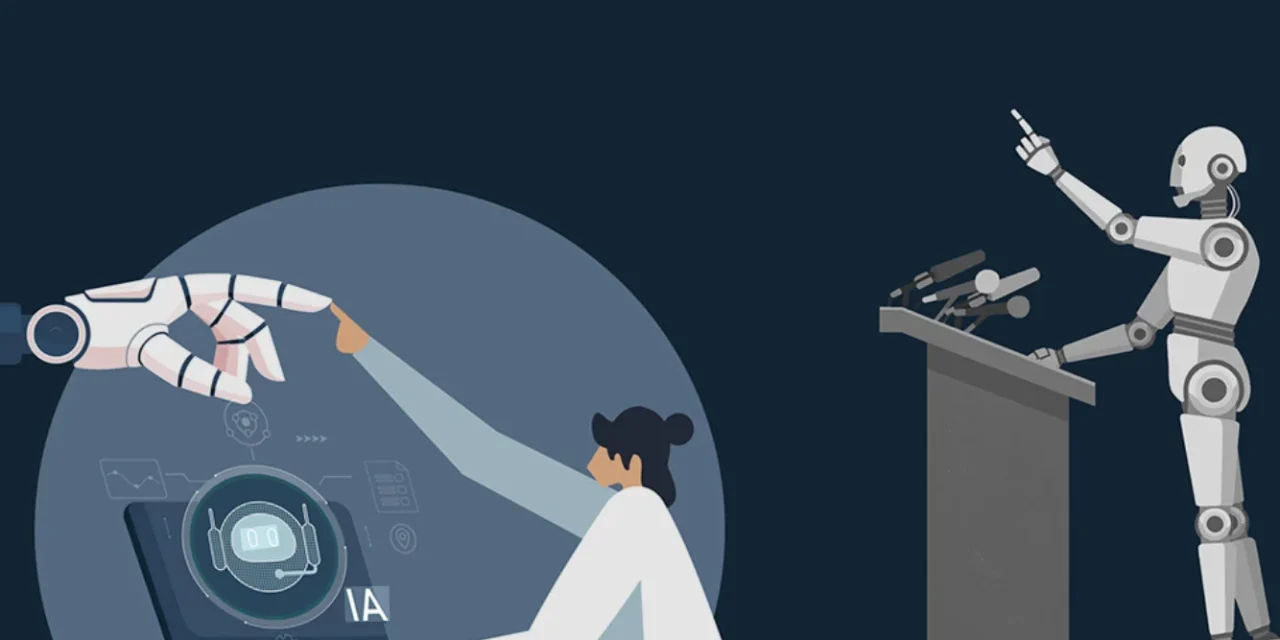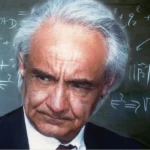Ci sono annunci che assomigliano a una previsione e invece sono una notifica. Quando Dario Amodei, alla guida di Anthropic, dice che l’intelligenza artificiale potrebbe spostare “la metà” dei lavori di colletti bianchi entry-level entro cinque anni, non sta solo descrivendo un possibile futuro: sta segnalando che il presente ha già imboccato un binario e che la locomotiva corre più veloce del dibattito pubblico. Intanto, mentre le cronache si accendono sulle contorsioni geopolitiche di Trump e sulle nuove grammatiche dell’ordine interno, l’economia dell’IA avanza come una mareggiata: senza titolo in prima pagina, ma con un’energia sufficiente a riscrivere le biografie di milioni di persone.
Lo si vede nei dettagli che, sommati, fanno sistema: licenziamenti che crescono, neolaureati che arrancano, carriere che iniziano più tardi e peggio, un senso di precarietà che non è più l’eccezione di una periferia sociale ma la condizione ordinaria di un’intera generazione “istruita”. E lo si sente in un altro segnale, più sottile e più corrosivo: anche chi resta impiegato scopre che i propri risparmi, la pensione, perfino l’idea di sicurezza futura dipendono sempre di più dalle fortune di una manciata di aziende tech ad alta crescita. È un paradosso crudele: temiamo l’IA come causa di insicurezza, e intanto la finanziamo indirettamente perché l’equilibrio del nostro benessere è appeso alle sue quotazioni.
Per questo la rivoluzione dell’IA, anche se non farà vincere o perdere i midterm, quasi certamente marcherà le presidenziali del 2028. Non sarà il tema più rumoroso, ma sarà quello più profondo: quello che tocca lavoro, status, futuro dei figli, dignità. E, come spesso accade, ciò che tocca la dignità diventa politica anche quando la politica finge di non vederlo.
Qui si apre una finestra che la storia americana conosce bene: quando un partito non intercetta una trasformazione economica, paga la distrazione in moneta elettorale. I democratici ne portano ancora i segni addosso. Globalizzazione, automazione, internet: tre onde che hanno eroso l’America operaia e hanno trasformato il rancore in identità politica consegnandolo, per anni, al populismo repubblicano. Da allora il campo progressista è apparso sempre più “urbano”, professionale, cosmopolita; e ha rischiato di perdere ciò che una volta lo rendeva riconoscibile: essere il partito degli scontenti, di chi non ha voce quando l’economia cambia pelle.
Ora la storia minaccia di ripetersi, con una differenza decisiva: questa volta non trema soltanto la fabbrica. Trema lo studio legale, l’ufficio contabile, la redazione, il reparto marketing, la consulenza, l’amministrazione. Trema l’architettura invisibile della classe media professionale, che è anche uno dei pilastri della coalizione democratica. Se l’IA diventa l’ennesima “fatalità” raccontata come inevitabile, il contraccolpo sarà inevitabile davvero. Perché nulla irrita più di sentirsi dire: non hai agenzia, adattati. È il linguaggio perfetto per generare rabbia.
Ed è qui che la politica deve smettere di inseguire lo spettacolo dell’innovazione e cominciare a fare ciò che è chiamata a fare: governare l’infrastruttura. Perché l’IA non è (più) soltanto un prodotto. È un’infrastruttura che sta diventando essenziale, come lo sono stati le ferrovie, le telecomunicazioni, l’energia. Quando una tecnologia diventa infrastruttura, smette di essere solo business e diventa questione pubblica: regole, responsabilità, trasparenza, controllo democratico. Altrimenti accade sempre lo stesso: la ricchezza si concentra, il rischio si socializza, la frustrazione si politicizza.
Il punto, allora, non è “fermare l’IA” – slogan sterile e tecnicamente improbabile – ma rifiutare l’idea che l’IA sia una natura che cade dal cielo. È una costruzione umana: quindi è modellabile. E modellabile significa che qualcuno paga e qualcuno guadagna, che qualcuno decide e qualcuno subisce. Le domande, in fondo, sono brutalmente semplici.
Chi è responsabile? Non si può accettare che pochi amministratori delegati, non eletti e opachi, determinino il mercato del lavoro e la struttura sociale come se fosse un effetto collaterale del progresso.
Chi ne beneficia? Se l’IA produce un gigantesco trasferimento di ricchezza verso l’alto – e tutti gli indizi puntano lì – allora lo Stato deve avere il coraggio di redistribuire, non come punizione del successo ma come manutenzione della democrazia: salute, casa, servizi, sostegno alle famiglie, e perfino un “dividendo” sociale che riconosca un fatto imbarazzante ma reale: quei modelli vivono anche di dati e contenuti generati da una moltitudine.
Chi diventiamo? Perché il lavoro non è soltanto reddito. È identità, appartenenza, trama quotidiana. Se le carriere si rarefanno, la solitudine cresce, e con la solitudine cresce la tentazione di affidarsi a tribù identitarie e vendette politiche. Qui la risposta non può essere solo economica: servono istituzioni che ricompongano la vita comune, investimenti in spazi civici, servizio, legami reali. Una società senza luoghi diventa un feed.
A sorprendere, semmai, è l’inerzia di chi dovrebbe correre. Mentre alcuni repubblicani fiutano il tema – per esempio con proposte che impongano almeno di dichiarare i licenziamenti legati all’IA – molte élite democratiche sembrano ancora inchiodate tra due tentazioni: o l’adesione timida al verbo dell’innovazione (“non possiamo frenare”), o la critica generica a Big Tech senza una piattaforma concreta. Ma non basterà indignarsi: occorrerà scegliere, e scegliere significa scontentare qualcuno. In particolare, significa non farsi intimidire da quel lobbying colossale che lavora per disinnescare regole prima ancora che esistano.
Nel frattempo, la coalizione degli scontenti cresce già, silenziosamente. Potrebbe includere il giovane programmatore senza contratto stabile e l’impiegato amministrativo sostituibile, il neolaureato che non trova un ingresso e il quarantenne che teme l’uscita, la periferia operaia e il centro urbano professionale. Una coalizione così, in teoria, potrebbe diventare maggioranza. Ma soltanto a una condizione: che la politica offra responsabilità e speranza. Non solo qualcuno da incolpare, ma qualcosa per cui valga la pena lottare.
Perché l’IA, prima di essere una tecnologia, è un test morale e democratico: o diventa strumento di prosperità condivisa, oppure si trasforma nella più efficiente macchina di mobilità verso il basso mai costruita. E allora sì: non sarà l’IA a decidere le elezioni del 2028. Sarà la risposta – o il silenzio – della politica.