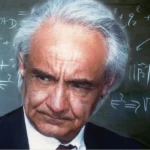C’è un’impressione che torna, a ogni nuovo eccesso: che sia etimologicamente e moralmente impossibile scendere ancora. Come se, a un certo punto, persino la realtà dovesse opporre resistenza. E invece no: la politica contemporanea – quando si lascia colonizzare dall’istinto, dall’ego, dalla crudeltà travestita da comicità – scopre sempre un gradino ulteriore. Non è solo “uno scivolone”: è il metodo. È la logica di un potere che non argomenta, marchia; non governa, umilia; non persuade, infetta.
L’episodio del video comparso su Truth Social – Barack e Michelle Obama ridotti a primati in una giungla, confezionati come gag, incastonati dentro il vecchio rosario di teorie tossiche sulle elezioni – è, in questo senso, più di una volgarità razzista. È un sintomo politico. La conversione del conflitto democratico in zoologia morale: l’avversario non va confutato, va disumanizzato. E quando la disumanizzazione diventa intrattenimento, la democrazia non è più una disputa: è un’arena.
Il copione è sempre lo stesso: prima l’azzardo, poi la finta ingenuità, infine la manovra di scarico. “È stato lo staff.” “È un meme.” “Indignazione finta.” La linea difensiva dell’era digitale è questa: far passare il veleno come folklore. Ma qui il folklore non c’entra. Perché la scelta di rilanciare un contenuto del genere – e di farlo dal più alto ufficio del Paese – produce un effetto che non si cancella con un clic: legittima un linguaggio. E il linguaggio, quando è governato dall’alto, scende a valle.
La reazione, perfino dentro il Partito repubblicano, è interessante non tanto perché improvvisamente virtuosa, quanto perché rara. È il segnale che l’eccesso, ogni tanto, rompe persino la disciplina della paura. Non è facile dissentire in un sistema dove il capo chiede fedeltà come un signore medievale e dove la comunicazione politica è spesso un referendum quotidiano sulla purezza. Eppure, quando un senatore nero come Tim Scott parla di “una delle cose più razziste” viste “da questa Casa Bianca”, quando una parte del GOP chiede rimozione e scuse, significa che l’episodio non è un inciampo di comunicazione: è una frattura di immagine nazionale.
Ma la frattura vera è più profonda e più lenta: è l’abitudine. La normalizzazione dell’anomalia. Nel tempo, tutto diventa parte di un rumore di fondo: un’altra provocazione, un’altra risata, un altro “non era mia intenzione”. Si vive così in una democrazia che smarrisce i suoi anticorpi: la vergogna si consuma, l’indignazione si stanca, la realtà si assottiglia.
C’è poi un altro elemento, meno appariscente ma decisivo: l’ossessione del nome. Il leader che “timbra” le cose – istituzioni, edifici, simboli – come se lo Stato fosse una proprietà privata, come se la Repubblica fosse un brand. È una vecchia pulsione imperiale: non basta vincere, bisogna marchiare. Il nome come possesso, il possesso come identità, l’identità come rivincita. E qui il passaggio è sottile ma cruciale: quando la politica diventa narcisismo amministrato, la verità diventa un impiccio. Non si cerca ciò che è; si impone ciò che conviene.
Da questo punto di vista, persino la confessione sull’ego – il bisogno di “dover vincere” perché perdere sarebbe stato intollerabile – non è una gaffe: è un autoritratto. La crisi della verità pubblica come prolungamento di una fragilità privata. Il dramma è che l’ego individuale, quando ha in mano leve istituzionali, diventa ingegneria della realtà: produce sfiducia nelle elezioni, sospetto nelle istituzioni, cinismo nel discorso civile. E il mondo, ancora oggi, paga gli interessi di quella svalutazione.
Il punto non è neppure la psicologia del personaggio – che sarebbe, per definizione, un vicolo cieco – ma l’ecosistema che lo rende possibile: una politica ridotta a “feed”, dove il linguaggio viene progettato per far male, non per capire; per dividere, non per deliberare; per eccitare, non per servire. In quell’ecosistema, il razzismo non è solo un pregiudizio: è una strategia di mobilitazione.
E poi c’è l’ombra lunga del caso Epstein, che in America continua a funzionare come una prova al tornasole: chi invoca “andare avanti” quando la domanda riguarda giustizia e responsabilità, non sta semplicemente archiviando un fatto. Sta suggerendo un principio: ci sono verità che non conviene cercare, e dunque non si cercano. Anche questo è un segno di governo, non una battuta. Perché una democrazia vive di due cose: responsabilità e memoria. Se le sottrai, resta solo lo spettacolo.
Alla fine, ciò che inquieta non è solo l’ennesimo contenuto indecente, ma il suo messaggio implicito: la politica come licenza di degradare. E qui l’elzeviro, se vuole essere fedele al suo compito, deve dirlo senza compiacimenti: una nazione non si disfa in un giorno, ma si corrode nella ripetizione dei gesti “piccoli” che autorizzano i gesti “grandi”.
Il post può essere cancellato.
Il danno, no. Perché il danno non è il video: è l’idea che un presidente possa parlare al Paese con quel registro – e farla franca. Quando accade, non è lui soltanto che scende più in basso: è il terreno comune della convivenza civile che si abbassa con lui.