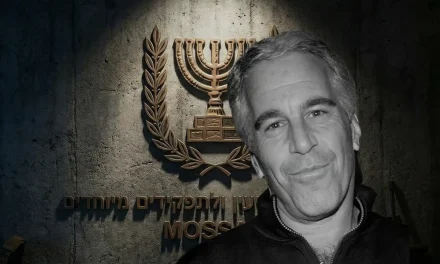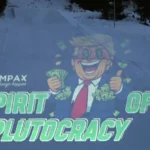La frattura tra Arabia Saudita ed Emirati Arabi Uniti non somiglia alle vecchie spaccature del Golfo, rumorose e ideologiche. È più moderna e quindi più pericolosa: è una rivalità di modello economico, di primato regionale, di catene logistiche e rendite future. Non farà titoli come una guerra aperta, ma può deformare per anni le mappe della sicurezza dal Mar Rosso al Corno d’Africa, trasformando conflitti locali in partite per procura e facendo saltare il fragile equilibrio su cui poggiano investimenti, rotte commerciali e “normalizzazioni” diplomatiche.
Per un decennio abbiamo raccontato Riyadh e Abu Dhabi come una diarchia: due monarchie pragmatiche, allineate contro l’Iran, diffidenti verso l’islam politico, capaci di usare denaro e influenza come strumenti di stabilizzazione (o di controllo). Poi è arrivato il punto di rottura: non un singolo evento, ma un cambio di paradigma. L’Arabia Saudita, con Vision 2030, ha smesso di essere soltanto una potenza energetica che finanzia il futuro; ha deciso di diventare il futuro. E per farlo deve fare ciò che ogni potenza emergente compie prima o poi: scalzare un concorrente già seduto sul trono del “post-petrolio”. Quel concorrente, nel Golfo, ha un nome preciso: Emirati Arabi Uniti.
La rivalità, infatti, non nasce dalla geopolitica tradizionale, ma dall’economia politica. Dubai e Abu Dhabi hanno costruito in decenni ciò che Riyadh vuole comprimere in pochi anni: finanza, logistica, turismo, attrazione di talenti, zone franche, brand globale. Per gli Emirati, quel primato non è un ornamento: è la garanzia della loro proiezione internazionale. Per i sauditi, è l’ostacolo principale al loro salto di status. È una competizione “a somma limitata”, perché la regione — e una parte del mercato globale — non può sostenere indefinitamente due hub equivalenti che aspirano agli stessi capitali, alle stesse sedi regionali, agli stessi flussi.
Da qui la prima conseguenza: una guerra economica a bassa intensità, fatta di regole e di dettagli. Barriere non tariffarie, requisiti per i contratti pubblici, incentivi per spostare headquarters, tariffe che colpiscono indirettamente i vantaggi altrui. È la diplomazia del modulo e del permesso, più efficace di molte note verbali. Il messaggio implicito è: se vuoi il mercato saudita, devi essere saudita — o almeno devi spostarti a Riyadh. E quando le multinazionali obbediscono, la rivalità smette di essere teoria: diventa redistribuzione concreta di potere.
La seconda conseguenza è politica: per attirare capitali, l’Arabia Saudita ha bisogno di prevedibilità. Il capitale detesta l’imprevisto più della tassazione; e Vision 2030, per riuscire, deve sedurre investitori che non vogliono svegliarsi con un drone sul terminal petrolifero o con una crisi sullo stretto che blocca le assicurazioni marittime. Ecco perché Riyadh ha iniziato a inseguire una narrativa di “stabilità”: riavvicinamenti, de-escalation, diplomazia con ex avversari. Non è conversione ideologica: è disciplina economica.
Abu Dhabi, invece, resta fedele a una logica diversa: contenere l’islam politico e preservare la propria rete di influenza. Laddove i sauditi cercano calma per far decollare cantieri e megaprogetti, gli emiratini cercano controllo sugli equilibri regionali. E stabilità e controllo non sempre coincidono: talvolta la stabilità richiede compromessi con attori “scomodi”; il controllo, al contrario, richiede impedire che quegli attori guadagnino spazio.
È così che la competizione economica si trasferisce nei dossier di sicurezza: Sudan, Siria, Yemen, Israele-Palestina. Qui la rivalità diventa più pericolosa perché si gioca per procura, cioè attraverso alleati locali armati, finanziati, legittimati. Non serve un conflitto diretto tra due Stati del Golfo per destabilizzare la regione; basta che i loro interessi divergenti attraversino gli stessi teatri.
Nel Sudan, ad esempio, il criterio non è “chi porta pace”, ma “chi non consegna spazio politico agli islamisti” per Abu Dhabi, e “chi stabilizza senza creare onde” per Riyadh. In Siria, per i sauditi la ricostruzione è un investimento sulla stabilità — anche se il leader è un ex jihadista “riciclato” in statista — mentre gli emiratini guardano al pedigree ideologico e al rischio che la nuova Siria diventi incubatrice di reti a loro ostili. Su Israele, Abu Dhabi procede nella normalizzazione pragmatica, mentre Riyadh mantiene la condizione palestinese come requisito politico e simbolico: non solo per ragioni di politica estera, ma perché la leadership saudita nel mondo islamico non può permettersi di sembrare “secondaria” su quel dossier.
Il vero punto di non ritorno, però, è lo Yemen. Per anni è stato il teatro della cooperazione: stesso nemico (gli Houthi), stessa cornice. Poi, quando la guerra ha consumato la sua narrazione originaria e sono emerse le fratture locali, le rispettive pedine hanno iniziato a combattersi fra loro. È il destino dei conflitti per procura: quando l’obiettivo comune sfuma, resta la competizione per l’influenza sul terreno. E lì le alleanze si riallineano, spesso con brutalità. Se Yemen significa Mar Rosso, Bab el-Mandeb, corridoi commerciali, allora non è più un dossier periferico: è un nervo del sistema globale.
A questo punto la domanda non è “scoppierà una guerra tra sauditi ed emiratini?” Probabilmente no. La domanda è più inquietante: quante crisi regionali possono sopportare due potenze che si contendono lo stesso futuro? Perché la rivalità tenderà a riprodursi ovunque ci siano porti, rotte, investimenti, governi fragili, milizie disponibili. E ogni volta che i due modelli si scontrano — stabilità per capitali contro controllo contro islamisti — il risultato non è equilibrio: è attrito.
C’è poi un fattore psicologico che in Medio Oriente conta quanto un memorandum: la competizione personale. Quando due leader si percepiscono come rivali di statura — e non più come alleati di progetto — anche i compromessi tecnici diventano questioni di prestigio. Ogni concessione assomiglia a una resa, ogni mediazione a una perdita di faccia. E nei sistemi politici personalizzati, la “faccia” è capitale.
Che cosa dovrebbe fare l’Occidente? La tentazione, come sempre, è scegliere un vincitore: puntare su chi compra più armi, investe di più, promette più contratti. Sarebbe un errore. Schierarsi alimenta la spirale: chi si sente retrocedere cercherà compensazioni altrove, e oggi “altrove” significa Cina — investimenti, tecnologia, accesso logistico, magari in futuro anche posture militari. In un Golfo che controlla energia e rotte, perdere l’equilibrio tra i due significa perdere leva su entrambi.
L’unica strategia sensata è “coprirsi” — tenere aperti i canali con entrambi, evitare narrazioni pubbliche che suonino come preferenze, e soprattutto investire nella de-escalation dei teatri dove la rivalità si scarica. Non per moralismo, ma per interessi concreti: una crisi nel Mar Rosso o nel Corno d’Africa non è un problema “regionale”, è un costo globale.
Infine, un realismo che vale più di molte analisi: sauditi ed emiratini hanno bisogno l’uno dell’altro più di quanto ammettano. Se la competizione economica è inevitabile, la gestione dei rischi dovrebbe essere cooperativa: coordinamento su logistica e data center, patti minimi sui teatri di guerra, regole d’ingaggio indirette per evitare escalation tra proxy. Non una pace sentimentale, ma una convivenza regolata.
Perché il Golfo, oggi, non è solo un luogo: è un interruttore. E quando due mani diverse iniziano a contendersi lo stesso interruttore, il rischio non è che si spenga la luce a Riyadh o ad Abu Dhabi. È che salti il quadro ben oltre il Golfo.