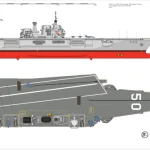C’è un dettaglio che pesa più di mille analisi: in Texas, la roccaforte che per anni ha funzionato da cassaforte politica e da immagine di “ordine”, un seggio considerato inattaccabile è stato capovolto da un democratico in un distretto che alle presidenziali aveva premiato Trump con un margine largo. Un episodio locale, diranno. Ma è proprio così che iniziano le crepe: quando la geografia del consenso smette di essere un muro e diventa un terreno.
Il punto non è il nome del candidato vincente, né la contingenza del meteo, né la solita consolazione dei “bassi affluenti”. Il punto è che l’immigrazione — usata come clava identitaria e come promessa di sovranità — comincia a produrre l’effetto opposto: non compatta, logora. E lo fa proprio dove doveva funzionare meglio, nel luogo-simbolo in cui la politica del confine è stata raccontata come virtù naturale, quasi antropologica.
Mentre in Texas si rompe l’automatismo, nel Nord si incrina la disciplina: in Minnesota un candidato repubblicano alla carica di governatore, Chris Madel, si ritira denunciando apertamente le operazioni dell’ICE come un “disastro totale” e parlando di “ritorsione” del partito nazionale contro i cittadini del suo Stato. Quando un repubblicano usa questa lingua, non sta facendo poesia: sta certificando che la macchina politica, nel tentativo di mostrarsi inflessibile, sta diventando indigeribile anche ai propri.
E qui la contraddizione diventa strutturale. La repressione — o, per usare un termine più neutro, l’iper-enforcement — produce consenso solo finché appare ordinata, proporzionata, “giusta”. Quando invece genera episodi controversi, immagini di arbitrarietà, narrazioni che non tornano, allora la forza smette di sembrare sicurezza e comincia a somigliare a paura amministrata. È in quel passaggio che il potere perde credibilità: non perché diventi “troppo forte”, ma perché appare troppo poco legato.
I sondaggi registrano questa erosione: non è un crollo improvviso, è una discesa lenta, che però ha una qualità politica particolare perché avviene mentre Trump è al potere e non in campagna elettorale. È la fatica del quotidiano: il momento in cui le persone non giudicano più lo slogan, ma gli effetti collaterali.
E tuttavia Trump resterà al potere. Proprio qui sta il nucleo del problema: la “caduta” di cui si parla non è istituzionale, è morale e civile. È la caduta di un’idea di presidenza come funzione limitata dalla legge, dai contrappesi, dalla grammatica delle istituzioni. In un’intervista, Trump ha detto che l’unico vincolo al suo potere sarebbe “la mia moralità, la mia mente”, come se i limiti non fossero la Costituzione e i controlli, ma la sua autocoscienza. È una frase che non è un eccesso retorico: è un programma implicito. Se il limite sono io, allora tutto il resto è negoziabile.
Per questo il “fallimento del Texas” — se così lo si vuole chiamare — non è una semplice sconfitta elettorale. È un segnale: indica che perfino l’elettorato più abituato al linguaggio del pugno duro comincia a chiedersi quanto costa, in libertà e in reputazione democratica, un potere che pretende di auto-limitarsi. E quando la politica si auto-limita, lo sappiamo da sempre, lo fa solo fino a quando conviene.
Il paradosso è che Trump può anche restare, ma restare non significa più governare su un terreno solido. Significa presiedere un Paese in cui il consenso si frantuma ai bordi, dove la “frontiera” diventa un boomerang e la roccaforte si scopre vulnerabile. Il Texas, che doveva essere garanzia, diventa sintomo: non dell’avanzata dell’opposizione, ma della stanchezza di chi non vuole più una politica che confonde l’autorità con l’assenza di freni.
E quando l’unico freno dichiarato è la coscienza del potente, la storia ha già dato il suo verdetto: non è più una democrazia che si difende; è una democrazia che si affida. E affidarsi, in politica, è il modo più elegante per cominciare a perdere.