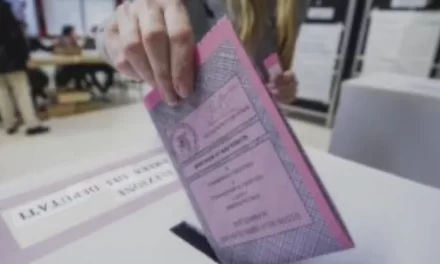Il ministro Valditara vuole schedare gli studenti palestinesi in Italia
C’è un punto in cui il linguaggio amministrativo smette di essere neutro e diventa politico. Accade quando una richiesta apparentemente innocua — “fornire dati numerici” — prende di mira un solo gruppo umano, definito per origine nazionale, mentre intorno infuria una guerra che ha già travolto ogni residuo di equilibrio morale. È qui che la nota del Ministero dell’Istruzione e del Merito sulla “presenza di studenti palestinesi” nelle scuole italiane smette di essere una procedura e comincia a somigliare a una schedatura.
La domanda che si impone è brutale nella sua semplicità: perché i palestinesi?
Perché non gli ucraini, non i siriani, non gli afghani, non i sudanesi? Perché proprio loro, proprio ora, mentre Gaza viene ridotta a macerie e il popolo palestinese è sottoposto a una distruzione sistematica che sempre più osservatori internazionali non esitano a chiamare genocidio?
Il problema non è solo giuridico, né solo educativo. È simbolico. Quando lo Stato chiede alle scuole di contare studenti in base all’identità nazionale — e solo quella palestinese — manda un messaggio preciso: quel gruppo è un’eccezione, una variabile da controllare, un potenziale problema. Non serve scriverlo: basta chiederlo.
Si dirà: è solo monitoraggio. Ma il monitoraggio, se non è motivato, esplicitato, condiviso e universale, diventa selezione. E la selezione, quando riguarda l’identità, scivola rapidamente nella discriminazione. È questo che rende la missiva inquietante: non ciò che dice, ma ciò che presuppone.
Siamo davvero arrivati al punto in cui, dopo il danno, arriva la beffa?
Mentre uno Stato — Israele — esercita una violenza militare senza precedenti su una popolazione civile, con pratiche che sempre più appaiono come terrorismo di Stato, in Italia i palestinesi diventano un “pericolo pubblico” da censire? Le vittime diventano sospetti. I bambini diventano categorie amministrative. Gli studenti diventano numeri da isolare.
È il parossismo di un rovesciamento morale.
La scuola, per Costituzione, non è un avamposto di sicurezza né un ufficio di polizia preventiva. È una comunità educante, fondata sull’eguaglianza, sull’inclusione, sulla tutela dei più fragili. Chiedere alle scuole di distinguere studenti su base etnica o nazionale — anche solo numericamente — significa incrinare questo patto originario. Significa abituare insegnanti e dirigenti a pensare in termini di categorie umane “sensibili”, e dunque a normalizzare l’idea che alcune identità vadano controllate più di altre.
È per questo che le reazioni della Flc Cgil e della Rete degli studenti medi colgono nel segno quando parlano di razzismo di Stato esercitato con il lessico asettico della burocrazia. La storia europea ci ha insegnato che le persecuzioni non iniziano con i rastrellamenti, ma con i registri. Con le liste. Con le richieste “tecniche”. Con le eccezioni giustificate dall’emergenza.
C’è poi un altro livello, ancora più grave: quello politico-culturale. Questa iniziativa si inserisce in un clima in cui la causa palestinese viene sistematicamente delegittimata, criminalizzata, associata al terrorismo per semplice prossimità identitaria. Non contano più le persone, ma l’etichetta. Non conta più la storia, ma l’appartenenza. È la logica della disumanizzazione, che comincia sempre con il linguaggio e finisce con l’esclusione.
E allora la domanda finale non è rivolta solo al ministro Valditara, ma all’intero Paese:
vogliamo davvero che la scuola italiana diventi il luogo in cui si impara a distinguere, a contare, a separare?
O vogliamo che resti — soprattutto nei tempi oscuri — lo spazio in cui si educa alla giustizia, alla compassione e alla verità?
Perché ogni censimento selettivo apre una breccia.
E ogni breccia, nella storia, è sempre stata seguita da qualcosa di peggio.