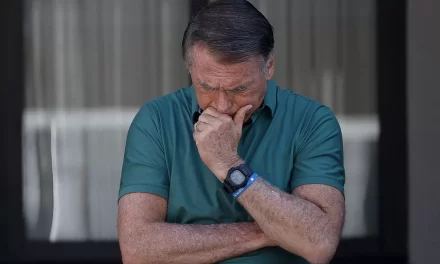La plutocrazia dinastica di una nazione che voleva esportare la democrazia nel mondo
L’alleanza tra Trump e l’Arabia Saudita ridefinisce i confini del potere globale: mentre le istituzioni americane arretrano, il presidente-businessman intreccia politica estera e affari privati, trasformando la diplomazia in un circuito di profitti miliardari.
Nel Golfo Persico la commistione tra politica e profitto è la normalità. Famiglie dinastiche, potere assoluto, nessun controllo democratico. Ma il fatto nuovo è che questa logica — che nel Golfo non fa notizia — è stata importata al centro della democrazia americana, fino a diventare il codice operativo del secondo mandato di Donald Trump.
La scena che si apre domani è emblematica: Trump incontra Mohammed bin Salman per «delicati colloqui sulla sicurezza nazionale». Eppure lo stesso leader saudita è colui che supervisiona Diriyah, un mega-progetto immobiliare da 63 miliardi di dollari dove la Trump Organization sta trattando l’apertura di una proprietà a marchio Trump. Diplomazia e affari privati, nello stesso dossier. Nessun firewall.
Da quando Trump è tornato al potere, le operazioni immobiliari che lo riguardano hanno conosciuto un’espansione quasi vertiginosa. Dar Global, società con legami diretti con il governo saudita, ha presentato progetti Trump a Jeddah, a Riyadh, persino alle Maldive. Ogni annuncio è accompagnato da royalties che finiscono, almeno in parte, direttamente nelle tasche del presidente. La politica estera non è più un’arena separata: è diventata una piattaforma di branding.
Eppure la cosa più sorprendente non è la gigantesca mole di denaro in circolazione. È la normalizzazione dell’anomalia.
Trent’anni fa bastava un investimento in futures agricoli — quello di Hillary Clinton — per scatenare settimane di indignazione. Oggi Jeff Bezos finanzia un film promozionale su Melania Trump con 28 milioni di dollari e Washington alza a malapena un sopracciglio. La saturazione di scandali ha reso l’opinione pubblica insensibile. Troppo rumore, troppe ombre, nessun tempo per pensare.
Gli studiosi di etica pubblica sono sgomenti. Michael Johnston, tra i massimi esperti di corruzione, arriva a parlare di «caso senza precedenti nella storia americana». Fred Wertheimer, altrettanto diretto, sostiene che nulla si avvicini all’uso personale della presidenza portato avanti da Trump. Le loro parole non generano reazioni perché Trump ha costruito un sistema corazzato: la rimozione degli ispettori generali, la politicizzazione del Dipartimento di Giustizia, l’indebolimento della burocrazia indipendente e la fedeltà di un Congresso repubblicano che non intende aprire indagini.
Senza contrappesi, l’impunità diventa metodo di governo.
Jared Kushner, il genero-banchiere, allarga il quadro. Di fronte alle accuse di conflitto d’interesse, risponde che ciò che gli altri chiamano corruzione, lui la considera «esperienza e relazioni di fiducia». È l’etica del Golfo applicata agli Stati Uniti. In questa visione il potere è personale, non istituzionale; la presidenza è un brand, non una funzione pubblica; la diplomazia è un’estensione degli affari familiari.
È qui il punto politico decisivo: il sistema americano sta assorbendo la logica del capitalismo dinastico tipica delle monarchie petrolifere. Non è solo la famiglia Trump a cambiare. È l’architettura democratica che, pezzo dopo pezzo, si adatta a una forma di governo dove la distinzione tra Stato e patrimonio personale si assottiglia fino a sparire. L’interesse nazionale si trasforma in interesse privato, mentre l’etica pubblica diventa un optional.
Il rischio non è marginale. Significa piegare la politica estera alla geografia dei profitti.
Quando l’Arabia Saudita finanzia la famiglia Trump, diventa legittimo chiedersi quale ruolo abbiano ancora i diritti umani, la guerra in Yemen, la strategia energetica o le tensioni regionali. Se ogni viaggio produce un nuovo annuncio commerciale, dove finisce la diplomazia e dove cominciano gli affari?
La verità più inquietante, però, è un’altra: il sistema non reagisce. Non perché approvi, ma perché è esausto. La democrazia americana non è stata “corrotta”: è stata stordita. Gli scandali non travolgono più la politica perché la politica è diventata un flusso continuo di scandali. L’indignazione non è morta: è stata sopraffatta.
Trump non è solo un’eccezione. È un sintomo.
Ha dimostrato che, anche in un Paese con solidi anticorpi democratici, può affermarsi un modello di governo in cui il potere serve il portafoglio, e non il contrario. Un modello in cui il confine tra Casa Bianca e azienda di famiglia è una linea tratteggiata, cancellabile a piacere.
È questa la vera trasformazione in corso: non una crisi etica, ma una mutazione strutturale del potere. E finché il sistema non tornerà a pretendere trasparenza, indipendenza e controllo, la politica rischierà di diventare sempre più simile ai regimi del Golfo: un’arena dove tutto è negoziabile, tranne l’interesse personale di chi governa.