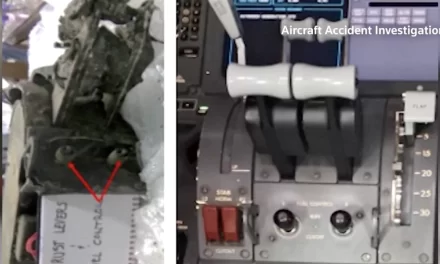L’ICi sta andando fuori controllo e Trump è preoccupato. La Noem, tuttavia, rimane al suo posto malgrado alcune purghe del governo
Minneapolis non è solo una città del Midwest. È diventata, ancora una volta, il luogo dove l’America scopre il proprio limite. Qui Donald Trump è stato costretto a fare ciò che detesta di più: arretrare, anche se chiamandolo con un altro nome. “De-escalation”, la definisce. In realtà è un passo indietro imposto dalla realtà, non dalla volontà.
La scintilla è stata la morte di Alex Pretti, infermiere dei veterani, ucciso da agenti federali mentre veniva immobilizzato a terra. Non un clandestino, non un terrorista, non un criminale armato. Un cittadino americano, con un cellulare in mano. Da lì, la piazza: centomila persone scese in strada nonostante il freddo, contro una presenza federale percepita come occupazione, non come protezione. La polizia locale in aperto conflitto con l’ICE. Il cortocircuito perfetto.
Trump ha capito di essere finito all’angolo. Non per le proteste in sé — che ha sempre considerato rumore di fondo — ma per l’effetto combinato di immagini, testimonianze, errori comunicativi e vittime. Deportazioni di bambini, anziani portati via nella neve, una donna morta, poi l’uccisione di Pretti. Troppo. Persino per una base Maga abituata alla retorica dell’uomo forte.
Così arrivano le prime teste simboliche. Via Gregory Bovino da Minneapolis, l’architetto dei raid più brutali. Dentro Tom Homan, lo “zar del confine”, volto della linea dura ma anche figura incaricata ora di ricucire con il governatore e il sindaco. Non una resa, ma un cambio di facciata. Trump lo dice chiaramente: “Non è un ritiro”. E proprio questa frase tradisce il problema. Quando devi spiegare che non stai arretrando, significa che lo stai facendo.
Ma non tutti pagano il prezzo. Kristi Noem resta al suo posto. La ministra della Sicurezza interna, nota per il culto delle armi e per una violenza esibita senza imbarazzo, viene difesa dal presidente come “efficace”. Eppure è lei ad aver definito Pretti un “terrorista domestico”. È lei il volto più aggressivo della guerra all’immigrazione. Ed è lei che oggi trascina verso il basso la credibilità dell’amministrazione. I democratici chiedono l’impeachment, i sindacati federali le dimissioni, una parte dei repubblicani parla apertamente di danno istituzionale. Ma Trump la salva. Perché Noem non è solo una ministra: è un simbolo identitario. Sacrificarla significherebbe ammettere che il problema non è stato un errore operativo, ma una visione.
Intanto, le armi continuano a sparare. In Arizona, la Border Patrol ferisce gravemente un’altra persona. La Casa Bianca è costretta a una prima, cauta ammissione: forse i protocolli non sono stati rispettati. Parole impensabili fino a pochi giorni fa. Segno che qualcosa si è incrinato.
Minneapolis racconta così il vero limite del trumpismo di governo. Funziona finché colpisce figure astratte: “clandestini”, “criminali”, “nemici interni”. Crolla quando il volto della vittima è riconoscibile, quando i video smentiscono la propaganda, quando la violenza non può più essere narrata come necessità.
Trump prova a salvarsi distinguendo, correggendo, limando. Ma il danno è fatto. E la frase di Joe Biden — “non siamo una nazione che uccide i propri cittadini per strada” — colpisce proprio lì dove fa più male: nella pretesa di rappresentare l’America profonda.
Minneapolis resta allora come monito. Non contro l’ordine, ma contro la confusione tra sicurezza e paura, tra Stato e forza bruta. Quando lo Stato spara per governare, prima o poi è costretto a fare un passo indietro. Anche se lo chiama de-escalation.