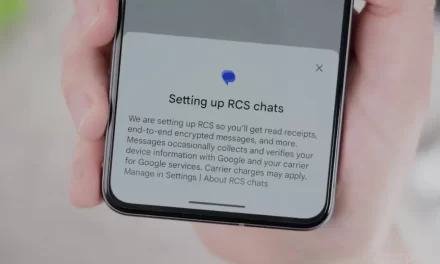C’è una ferita che si riapre ogni volta che una donna, un uomo, una madre viene travolta dalla violenza di uno Stato. E poi c’è una ferita secondaria, meno visibile ma altrettanto crudele: quella inflitta da chi trasforma il lutto in narrazione spuria, tecnica di distrazione, fango mediatico.
La drammatica uccisione di Renee Nicole Good, 37 anni, madre di tre figli, colpita mortalmente da un agente dell’ICE a Minneapolis lo scorso 7 gennaio, non è diventata solo un caso di cronaca tragica e controversa. È stata anche, immediatamente, territorio di speculazione. La condanna e la rivendicazione di differenti narrazioni — dalle accuse di “terrorismo interno” alle letture semplificate dei fatti — sono proliferate con sorprendente velocità.
C’è chi, fin dalle prime ore, ha cercato di definire i fatti in modo netto e giudicante: il Broadcasting conservatore statunitense, come riportato da Fox News, ha promosso il racconto delle autorità federali, enfatizzando che Good avrebbe usato la sua auto in modo pericoloso contro gli agenti e che la sua morte fosse una risposta di legittima difesa.
Ancora più esplicito – e manifesto esemplare di come si possa diffondere una narrazione marginale invece di restare ai fatti – è stato il commento del noto conduttore Fox News, Jesse Watters: la donna, pochi giorni dopo la sua morte, è stata definita “self-proclaimed poet with pronouns in her bio” — «poetessa autoproclamatasi con i pronomi nel profilo» — una frase che non si limita a descrivere, ma trancia via dignità e riduce una vita umana a una caricatura sociale.
Non è un dettaglio innocuo. È un modo per spostare l’attenzione da una questione di legittimità e uso della forza a una singola caratteristica personale che nulla dice sull’accaduto, ma tutto racconta delle priorità narrative di chi la propone: non chi era Renee Good, non cosa è accaduto davvero, ma una suggestione che serve più ad alimentare scontri culturali che a interrogarsi su ciò che resta di una vita spezzata.
Il New York Times stesso, pur non cadendo in questi abusi retorici, segnala come alcune alte cariche politiche — dalla segretaria alla Sicurezza Interna Kristi Noem al vicepresidente JD Vance — abbiano usato termini come “terrorista interno” o “deranged leftist”, trasformando la vicenda in epigrafe morale anziché caso investigativo da verificare con rigore.
Va riconosciuto però che giornali come The Guardian e MPR News hanno portato alla luce aspetti essenziali: la dinamica dei fatti, le contraddizioni tra le versioni delle autorità e quella dei testimoni e dei video registrati, la testimonianza di amici e familiari che ricordano Renee per ciò che era — madre, poetessa, vicina di casa, non una criminale.
Ma l’effetto complessivo della narrazione mainstream è stato di scarsa chiarezza: tra dichiarazioni ufficiali, tweet di esponenti politici e commenti di opinionisti in prima serata, la storia di una donna uccisa ha cominciato a somigliare a uno specchio di polarizzazione sociale più che a un’inchiesta rigorosa.
La lezione — dolorosa ma necessaria — è che il linguaggio conta. Trasformare in narrazione di distrazione la morte di una madre di tre figli non è un fatto accidentale: è un sintomo di un ambiente mediatico che preferisce l’iconografia al racconto, la polemica all’analisi, il carattere alla realtà.
Renee Nicole Good non merita soltanto un luogo nella cronaca; merita verità. Se il dolore della sua famiglia e il trauma dei suoi figli non bastano a richiederla, allora la responsabilità di chi scrive — e di chi legge — diventa ancora più alta: quella di non cedere alla macchina del fango, ma di continuare a chiedere chiarimenti su ciò che è accaduto davvero, e perché.