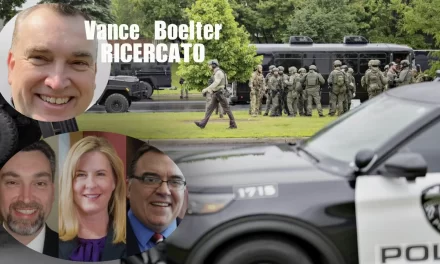In un Medio Oriente che sembra aver archiviato il linguaggio della politica per quello della forza, Mahmud Abbas continua a rappresentare una Palestina che insiste a esistere come Stato prima ancora che come causa. Novant’anni, venti di presidenza, poche illusioni e molte pressioni: la sua leadership è oggi più fragile che mai, ma anche più rivelatrice del vuoto che la circonda.
Quando Yasser Arafat scomparve, nel 2004, Abu Mazen appariva a molti come un uomo di passaggio: troppo prudente per l’epica palestinese, troppo istituzionale per un popolo abituato a leader simbolici. Eppure è ancora lì, dopo due decenni, mentre intorno tutto è cambiato. Non per forza carismatica, ma per mancanza di alternative capaci di tenere insieme territorio, riconoscimento internazionale e legittimità politica.
Il quadro che emerge oggi è quello di una leadership accerchiata. Da una parte Israele, che continua a ridisegnare la realtà sul terreno; dall’altra Hamas, che contesta all’Autorità nazionale palestinese ogni pretesa di rappresentanza; in mezzo una società giovane e disillusa che chiede un ricambio radicale senza che questo ricambio abbia ancora preso una forma chiara. Abbas governa più per inerzia che per consenso, ma è un’inerzia che evita il collasso.
Sulla guerra di Gaza e sul piano promosso dall’amministrazione Trump, Abu Mazen compie una scelta controcorrente: accetta l’orizzonte negoziale, incluso il superamento del controllo di Hamas, ma ne rilegge i passaggi in chiave statuale. Il messaggio è netto: le armi non possono appartenere a un movimento, ma solo a uno Stato legittimo. È una posizione che gli costa critiche interne, ma che rivela la sua ossessione politica fondamentale: trasformare la questione palestinese da emergenza permanente in architettura istituzionale.
Per questo rifiuta qualsiasi ipotesi di frammentazione di Gaza. Ogni linea tracciata, ogni amministrazione separata, ogni zona “speciale” è, nella sua visione, un colpo inferto alla possibilità stessa di uno Stato palestinese unitario. Gaza, Cisgiordania e Gerusalemme Est non sono capitoli separati, ma un’unica partita. Accettare il contrario significherebbe certificare la sconfitta definitiva del progetto nazionale.
Il tema più delicato resta quello democratico. Vent’anni senza elezioni pesano come un macigno sulla credibilità dell’Autorità palestinese. Abbas promette un ritorno alle urne, ma pone condizioni che molti giudicano elusive: sicurezza, fine delle aggressioni, possibilità di voto in tutti i territori occupati. Dietro queste cautele c’è una verità scomoda: elezioni senza sovranità rischiano di produrre nuove divisioni, non legittimazione.
Nel frattempo, la violenza dei coloni in Cisgiordania e l’espansione degli insediamenti continuano a erodere ogni spazio politico. Abbas chiede alla comunità internazionale qualcosa di semplice e radicale insieme: distinguere tra Israele come Stato e l’occupazione come pratica. È una richiesta che molti governi condividono a parole, ma che pochi traducono in atti concreti, come il riconoscimento dello Stato di Palestina.
Anche l’Italia, in questo scenario, resta sospesa. Dialoga, coopera, forma, assiste, ma non compie il passo politico che Abbas invoca. Non per ostilità, ma per prudenza. Una prudenza che, col tempo, rischia di trasformarsi in irrilevanza.
Mahmud Abbas non è più l’uomo del futuro palestinese. Forse non lo è mai stato. Ma oggi è il custode di un’idea che resiste a fatica: che la Palestina possa ancora nascere come Stato, e non come somma di macerie, milizie e amministrazioni provvisorie. Quando lascerà la scena, non sarà solo un presidente a uscire di scena. Sarà una certa grammatica della politica palestinese a dover trovare un nuovo interprete.